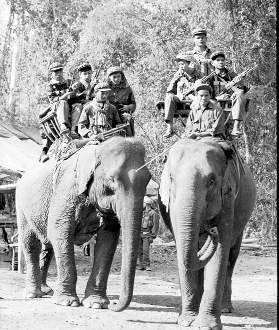 Per
Serge Latouche, «La civiltà occidentale, così come la conosciamo da
tre secoli, è molto diversa dalle altre. Si tratta infatti di una
società della crescita, cioè di un’organizzazione umana completamente
dominata dalla sua economia. E quest’ultima per rimanere in equilibrio,
ha una sola via, la fuga in avanti, come un ciclista che, se smette di
pedalare, cade a terra. Quando manca la crescita, nella società dei
consumi si blocca tutto» (Incontri di un “obiettore di crescita”, Jaca Book, 2013).
Per
Serge Latouche, «La civiltà occidentale, così come la conosciamo da
tre secoli, è molto diversa dalle altre. Si tratta infatti di una
società della crescita, cioè di un’organizzazione umana completamente
dominata dalla sua economia. E quest’ultima per rimanere in equilibrio,
ha una sola via, la fuga in avanti, come un ciclista che, se smette di
pedalare, cade a terra. Quando manca la crescita, nella società dei
consumi si blocca tutto» (Incontri di un “obiettore di crescita”, Jaca Book, 2013).
Il Capitalismo è in primo luogo e fondamentalmente una società
dominata dalla ricerca del massimo profitto possibile, e a causa di ciò
la sua struttura economico-sociale deve necessariamente subire
periodiche rivoluzioni. È la bronzea legge del profitto che sottopone
l’economia a continui mutamenti tecnologici e organizzativi, che sposta
sempre in avanti i confini del mercato, trasformando la vita stessa
degli individui, ridotti, se mi è concesso dire, a risorse economicamente sensibili,
in una merce. L’«immane raccolta di merci» di cui parlò una volta Marx
per definire la ricchezza sociale nella sua forma capitalistica, oggi,
nell’epoca della bio-merce (l’individuo come merce che produce merci e
che consuma merci: insomma, come merce perfetta) e della sussunzione totalitaria del lavoro sotto il dominio del Capitale, suona perfino riduttiva.
Il corpo stesso degli individui è, infatti, diventato una «immane
raccolta di merci», una verde prateria in continua espansione a
disposizione del cavallo capitalistico (il Capitale non conosce un
limite fisico, ma anzi esso crea sempre di nuovo spazio su cui
scorrazzare), un laboratorio che fa la gioia e la fortuna di chi per
mestiere inventa nuovi bisogni, nuovi desideri, nuove “utopie”, nuovi
sogni, nuove necessità.
Ma che fa anche la gioia e la fortuna di chi si guadagna il pane
aggiustando l’anima strapazzata di un «capitale umano» a sempre più
alta «composizione organica».
È la tetragona legge di cui sopra che fa del rapporto sociale
peculiare di questa epoca storica (Capitale-Lavoro) una disumana e
disumanizzante relazione di dominio e di sfruttamento. In questo senso è
verissimo che quella capitalistica è «un’organizzazione [dis]umana
completamente dominata dalla sua economia». Il Capitale come potenza
sociale astratta e impersonale che domina anche gli stessi agenti del
capitale, i capitalisti, è una realtà che viene in evidenza soprattutto
nei momenti di crisi economica, la quale impatta sulla società alla
stregua di una catastrofe naturale: inaspettata, violenta,
incontrollabile, dolorosa.
Definire il Capitalismo a partire dai concetti di crescita e di consumo, come fa Latouche, è dunque profondamente sbagliato: infatti, è quando manca la crescita dei profitti
che nella società basata sulla valorizzazione degli investimenti «si
blocca tutto». Il motore dell’economia capitalistica non è il consumo,
ma il profitto: è il saggio del profitto che regola, in ultima analisi,
l’andamento del ciclo economico, che espande o contrae gli investimenti
produttivi, che espande o contrae il mercato finanziario, speculazione
inclusa.
Per questo è semplicemente chimerico affermare che bisogna uscire
dalla società dei consumi, quando si tratta piuttosto di uscire dalla
società dei profitti, ossia dal Capitalismo tout court. D’altra
parte, non ci si può attendere altro da un intellettuale che alla
Conferenza all’Università di Roma del 7 novembre 2012 ha proposto
all’Italia la seguente ricetta per venire fuori dalla crisi: «Frugalità e
riaffermazione della supremazia della piccola impresa, che ha
rappresentato per cinquanta anni il tessuto connettivo del Paese, la sua
peculiarità».
«Accusarci di andare a caccia di chimere è profondamente ingiusto»
(p. 54): così risponde il guru francese della decrescita a chi gli
rimprovera uno scarso senso della realtà. Contro l’ideologia del TINA (There Is No Alternative),
Latouche sostiene il carattere realistico della decrescita. Sulla
sostanza chimerica e reazionaria dell’opzione decrescista sostenuta dal
Francese rimando a Capitalismo e termodinamica. L’entropia (forse) ci salverà.
Oltre che con i sostenitori del TINA, Latouche se la prende anche con
chi lo attacca da “sinistra”, proponendo una «nostalgia rivoluzionaria
[che] resta prigioniera di una visione manichea della realtà ereditata
dalla sinistra marxista, col suo schema di una lotta di classe ridotta
all’antagonismo borghesia/proletariato. Sfortunatamente le cose non
sono così semplici. Che ci siano conflitti di interessi irriducibili,
non saremo certamente noi a negarlo. Che una rivoluzione sia
necessaria, è altrettanto evidente. Tuttavia, questa rivoluzione come
la si farà? Contro chi? E contro cosa? Visto che siamo tutti vittime,
chi più chi meno, contagiati dal virus produttivista e consumista,
bisognerà prevedere lo sterminio del popolo al dettaglio in nome del
popolo nel suo insieme, secondo l’equazione matematica del terrore
formulata da Benjamin Constant e riattualizzata dai Khmer Rossi?» (Incontri di…).
Quanto sostiene Latouche la dice lunga, tra l’altro, sull’idea di
“marxismo” che egli ha in testa. I Khmer rossi rappresentano il migliore
cavallo di battaglia di Latouche nella sua polemica con i “marxisti”:
«Tutti i tentativi di modificare radicalmente l’immaginario, di
cambiarlo forzatamente, hanno avuto risultati terrificanti, come ha
dimostrato l’esperienza dei Khmer Rossi in Cambogia» (Decolonizzare l’immaginario). Interpretare in chiave anticapitalistica la mostruosa esperienza dei maoisti cambogiani è semplicemente ridicolo.
Come sa chi ha la bontà di leggere le mie modeste cose, a mio avviso
lo stalinismo, non importa se con caratteristiche russe, cinesi o
cambogiane, è l’esatto opposto di quella concezione rivoluzionaria del
mondo che Marx si sforzò di elaborare e praticare. L’intellettuale
francese può certamente avere la meglio su gran parte dei militanti
“marxisti” oggi in circolazione, in genere eredi di quel “comunismo” che
ha gettato nel più assoluto discredito l’idea stessa di una
emancipazione rivoluzionaria delle classi dominate e dell’intera
umanità; ma nei confronti dell’autentico punto di vista
critico-rivoluzionario (che, detto en passant, non ha bisogno di
definirsi con un nome), egli appalesa tutta la sua inconsistenza
dottrinaria e politica, tutto il suo infantilismo “filosofico”.
Alla base del genocidio cambogiano degli anni Settanta non ci fu,
come crede lo sprovveduto Latouche, una coerente quanto feroce utopia
anticapitalistica, ma un retaggio storico fatto di oppressioni e
violenze coloniali, di sfruttamento imperialistico, di nazionalismo
frustrato, di odio sociale tra campagna e città, di estrema miseria
urbana e rurale, di corruzione endemica e capillare, di vendette sociali
e personali lungamente coltivate. Tutte queste magagne sfociarono
nella parossistica chiusura nazionalista-contadina dei Khmer Rossi, i
quali si proposero di sradicare con la forza dal corpo sociale
cambogiano ogni inclinazione benevola nei confronti del «corrotto
occidente capitalistico». Una versione particolarmente estremista del
maoismo (caldeggiata soprattutto dalla moglie di Mao) costituì il
miserabile fondamento ideologico dell’ultranazionalismo Khmer, la cui
sanguinosa esperienza rappresenta un capitolo del Libro Nero del Capitalismo.
I giacobini pensarono che fosse possibile cambiare la «cattiva natura
dell’uomo» attraverso un mero sforzo di volontà, mediante una
illuministica rivoluzione culturale, senza cioè modificare radicalmente
le cause storico-sociali di quella natura. «Essi stavano sul filo d’una
grande contraddizione, e chiamarono in loro aiuto il filo della
ghigliottina … Essi credevano nella forza assoluta dell’idea, della
“verité”. E ritenevano che nessuna ecatombe umana sarebbe stata troppo
grande per costruire il piedistallo a questa “verité”» (Trotsky, Giacobinismo e socialdemocrazia).
Raddrizzare l’«albero storto» dell’individuo, anche a costo di
spezzarlo, è stato da sempre il sogno degli idealisti eticamente
motivati di tutte le tendenze politiche e filosofiche. La «rivoluzione
antropologica» a rapporti sociali invariati è la classica via per l’inferno lastricata di eccellenti intenzioni.
Per questo quando sento parlare molti fautori particolarmente
zelanti della «decrescita felice» circa l’urgenza di «cambiare
radicalmente i nostri pessimi valori, i nostri cattivi stili di vita,
le nostre cattive abitudini», non posso fare a meno di inquietarmi. La
mano corre istintivamente al collo, quasi in un gesto di
rassicurazione…
I militanti del punto di vista umano hanno capito che per liberarci
«dal virus produttivista e consumista»; per modificare radicalmente il
nostro «immaginario» alienato e reificato, occorre superare il vigente
rapporto sociale che tutto sfrutta, consuma, mercifica, inquina e
disumanizza. Per mutuare Marx, Latouche vuole emancipare l’uomo «dal
virus produttivista e consumista» solo «affinché l’uomo porti la catena
spoglia e sconfortante», mentre si tratta di gettare via la catena
capitalistica e cogliere i fiori vivi della Comunità Umana, oggi sempre
più possibile e, al contempo, sempre più negata. È in questa presa di
coscienza che, a mio avviso, si deve individuare la sola «rivoluzione
culturale» in grado di ripristinare il Tempo della Speranza.
È vero: anche in questa epoca dominata dalla totalitaria legge del
profitto si danno all’uomo delle alternative; la cattiva dimensione di
una vita non-ancora-umana non necessariamente è un destino
insuperabile. È altresì vero che l’”alternativa” proposta ormai da
parecchi anni da Latouche non esce neanche di un solo millimetro da
quella maligna dimensione, né sembra avere una concreta possibilità di
implementazione nel quadro stesso del vigente assetto sociale. Ai miei
occhi certe utopie (come la mia, ad esempio) appaiono molto più concrete
e realistiche di molte chimere riformiste informate dalla concezione
dei piccoli passi, ossia dall’illusione che attraverso piccole ma
concrete conquiste sociali l’umanità può affrancarsi dal Moloch
capitalistico. Perlomeno la mia utopia cerca di fare i conti fino in
fondo con il Dominio sociale come esso è secondo la sua intima
natura, e non come «potrebbe e dovrebbe essere» in base a criteri
economici, filosofici, etici e politici quantomeno discutibili e
certamente ideologici. Il realismo (dei “conservatori” e dei
“rivoluzionari”) non ci salverà, questo è, come si dice, poco ma sicuro.

Nessun commento:
Posta un commento