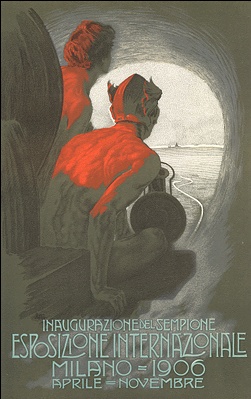Perché
il salvataggio delle banche è stato anteposto o, addirittura,
contrapposto al salvataggio delle persone? C’è una sola risposta
possibile: perché è prevalsa la legge del più forte. Una domanda
semplice, forse banale, e una una risposta altrettanto semplice, che ai
più appariranno ovvie. Ma che ovvie non sono
 Si
poteva pensare che due secoli abbondanti di costituzionalismo e di
espansione democratica avessero definitivamente espunto dal nostro
orizzonte sociale l’esercizio senza limiti del potere, secondo la legge
elementare del più forte. Sembrava che il potere assoluto e l’esercizio
arbitrario della forza fossero stati definitivamente sottratti al
sovrano assoluto e consegnati nelle mani del popolo, reso finalmente
sovrano, che lo avrebbe esercitato nel rispetto della libertà di tutti.
Si poteva supporre che nessun altro potere avesse diritto di
cittadinanza all’interno del contesto democratico. La sopraffazione era
bandita dalla sfera delle relazioni sociali. La democrazia
rappresentativa doveva garantire che il popolo potesse eleggere i propri
rappresentanti che avrebbero esercitato il potere di decidere per tutti
nell’esclusivo interesse dei cittadini e secondo la volontà
democraticamente espressa. L’unico potere che potesse essere
legittimamente esercitato era, dunque, quello conferito dalla delega del
popolo.
Si
poteva pensare che due secoli abbondanti di costituzionalismo e di
espansione democratica avessero definitivamente espunto dal nostro
orizzonte sociale l’esercizio senza limiti del potere, secondo la legge
elementare del più forte. Sembrava che il potere assoluto e l’esercizio
arbitrario della forza fossero stati definitivamente sottratti al
sovrano assoluto e consegnati nelle mani del popolo, reso finalmente
sovrano, che lo avrebbe esercitato nel rispetto della libertà di tutti.
Si poteva supporre che nessun altro potere avesse diritto di
cittadinanza all’interno del contesto democratico. La sopraffazione era
bandita dalla sfera delle relazioni sociali. La democrazia
rappresentativa doveva garantire che il popolo potesse eleggere i propri
rappresentanti che avrebbero esercitato il potere di decidere per tutti
nell’esclusivo interesse dei cittadini e secondo la volontà
democraticamente espressa. L’unico potere che potesse essere
legittimamente esercitato era, dunque, quello conferito dalla delega del
popolo.
Non è così e, forse, non lo è mai stato. Il sogno della democrazia si
è da tempo trasformato in un sonno tormentato da incubi. E i bruschi
risvegli, che sempre più spesso ci toccano, ci disvelano un mondo in cui
di democratico in senso proprio non c’è praticamente nulla,
specialmente se guardiamo alla sostanza del processo democratico, che
dovrebbe investire il modo in cui vengono prese le decisioni che
coinvolgono le condizioni e l’interesse di tutti e che, quindi,
dovrebbero quanto meno rispettare la volontà della maggioranza.
Vediamo invece all’opera gruppi ristretti di persone, spesso in
connessione fra di loro, che prendono decisioni la cui rilevanza è
decisiva per il destino di tutti e lo fanno al di fuori di qualsiasi
circuito democratico, senza essere sottoposti al alcuna verifica
democratica, né prima né dopo. I processi decisionali che contano sono
spesso occulti e tali restano anche dopo che le decisioni sono state
assunte. In breve, si è formata un’oligarchia, formata dai vertici del
potere economico-finanziario, politico, amministrativo, cui si
rivolgono, in una logica di scambio politico, i gruppi di interessi
dotati di sufficiente potere. A livello globale poi, ed è questa forse
la cosa più inquietante, si sta formando, nelle più totale mancanza di
trasparenza, un’élite del potere, un’oligarchia delle oligarchie,
composta di esponenti della finanza, dell’industria, della politica e,
forse, anche della comunicazione e delle religioni.
Questa evoluzione, che investe, seppur in forme diverse, tutti i
paesi formalmente democratici, è giunta oggi a un punto di rottura.
Viviamo in regimi formalmente democratici, in cui sono giuridicamente
garantiti i diritti che fanno parte del patrimonio democratico e in cui
si continuano a celebrare i riti caratteristici della democrazia: il
voto per eleggere i rappresentanti al parlamento e, a seconda dei casi
il capo del governo e il presidente della repubblica; le consultazioni
referendarie; i congressi dei partiti; le manifestazioni di piazza.
In
tutto ciò, non vi è alcun esercizio concreto del potere democratico né
vi è la formazione di una volontà collettiva che indichi un programma di
governo. Vi è solo la possibilità di aderire alle opzioni elaborate
all’interno delle oligarchie, schierandosi a favore di poteri e di
soluzioni di cui spesso non si conosce nulla. È appena il caso di
sottolineare che questo è il contesto in cui fiorisce la corruzione
quale necessario corredo e fondamentale strumento di scambi occulti
fatti sulla pelle e con i soldi dei cittadini.
Il potere economico
Tutto ciò è particolarmente vero e pertinente per quando riguarda
l’ambito dell’economia e, soprattutto, della finanza. Frastornati dalla
propaganda che elogia i mercati quali garanti della trasparenza e della
libera scelta di produttori e consumatori, affascinati dai risultati
delle imprese globali, abbiamo lasciato che nell’economia si formassero
aggregazioni di potere inaudite, con una potenza economica e finanziaria
che supera di gran lunga la forza della maggior parte degli stati nel
mondo. Il problema del gigantismo industriale, di istituzioni bancarie e
finanziarie gigantesche, è parte del capitalismo maturo e lo conosciamo
da tempo. Ma il fenomeno delle strutture economiche too big to fail,
troppo grandi per fallire, ha reso plasticamente evidente
l’insostenibilità democratica di questo contesto economico. Siamo in una
situazione limite, prossima al punto di rottura. Siamo di fronte a
organismi economici di natura privata, che prendono le loro decisioni e
compiono le loro scelte in vista di interessi esclusivamente privati,
generalmente di cerchie assai ristrette, ma ci viene detto, dagli
esponenti politici che abbiamo eletto, che quando questi organismi
sbagliano e vengono a trovarsi in difficoltà è l’intera collettività che
deve farsi carico di salvarle dal possibile fallimento. Profitti
privati e pubbliche calamità. È la legge del più forte. È il più forte,
più forte economicamente, che detta ai più deboli, il popolo, regole e
condizioni nel nome del proprio esclusivo interesse. L’asserzione che,
se il più forte fallisce, ne risente l’intera comunità e che, dunque, il
suo salvataggio rientra nella tutela dell’interesse collettivo è una
miserevole menzogna, che nessun argomento serio è in grado di sostenere.
Lo ripetiamo: la compatibilità fra sistema democratico ed economia
capitalistica è giunta a un punto di rottura. Dobbiamo esserne
consapevoli e dobbiamo porre apertamente il problema. Potrebbe essere
già troppo tardi per evitare passaggi difficili e socialmente costosi.
Il miraggio della concorrenza
La democrazia americana, che per prima si è esplicitamente confrontata con il problema del gigantismo economico, la bigness, ha tentato di domarlo imponendo le regole dell’antitrust, ritenendo che la disciplina della concorrenza fosse in grado di contrastare gli inevitabili abusi di potere cui la bigness dà luogo. Per più di un secolo, dal 1890 quando, sull’onda di una mobilitazione popolare, fu varata la prima normativa antitrust,
si è combattuta una guerra che non poteva essere vinta. È stata vinta
qualche battaglia, ma la guerra è stata persa, perché non si è riusciti a
contrastare efficacemente l’espansione del potere economico e il suo
traboccamento negli altri ambiti della vita sociale. Si è cercato
penosamente di giustificare la bigness, sostenendo che non è la
grande dimensione delle imprese, di per sé, che mette a rischio il
corretto funzionamento dei mercati addomesticando la concorrenza, ma
solo il suo abuso, che, dunque, va combattuto in quanto tale. Di fatto,
ci si è arresi allo strapotere delle corporation, rinunciando a
intervenire sulla loro crescita dimensionale, come pure qualche eroico
sostenitore della concorrenza, come il giudice Brandeis, aveva suggerito
un secolo fa. Oggi, il regime concorrenziale disciplina,
paradossalmente, solo coloro che non avrebbero bisogno di essere
disciplinati, in quanto privi di un effettivo potere di mercato.
L’antitrust, come tutti i sistemi di regole, rimane
costituzionalmente debole e perdente fintanto che si limita a
intervenire sugli effetti e non gli è consentito di aggredire le cause
delle grandi distorsioni che ostacolano il funzionamento della
concorrenza nei mercati. L’antitrust si riduce così a una narrazione che cerca di convincerci che siamo riusciti ad addomesticare il potere economico. L’antitrust,
come tutti i sistemi di regolamentazione dei mercati, è esposto a
pesanti asimmetrie informative che attribuiscono alle imprese,
specialmente quelle più grandi, un vantaggio pressoché incolmabile, che
non di rado tracima nella cattura del regolatore, costretto a decidere
sulla base delle informazioni che gli fornisce il regolato e sempre
esposto al rischio della corruzione.
Il risultato è che le mega-imprese che agiscono a livello globale
hanno di fatto assorbito tutte le dimensioni del potere e ne dispongono a
loro piacimento, senza dover rispondere a nessun sistema di regole,
semplicemente perché non c’è nessun regolatore che abbia la forza di
imporgli regole. Il potere politico e legislativo è interamente
riassorbito nello spazio economico e assoggettato agli interessi delle
grandi imprese. La mega-impresa globale è oggi di fatto un’entità
extra-territoriale, nel senso che non è soggetta in senso proprio ad
alcuna giurisdizione nazionale ed è, anzi, in condizione di mettere in
atto una sorta di “arbitraggio regolamentare”, privilegiando le
giurisdizioni più favorevoli sul piano giuridico e fiscale ed
esercitando così un irresistibile potere di condizionamento sulle scelte
dei governi.
Le imprese too big to fail semplicemente non dovrebbero
esistere. Nessun discorso onesto sulla libertà economica può arrivare
fino al punto di giustificare la formazione di queste abnormi
aggregazioni di potere. E invece esistono ed esiste uno stuolo di
economisti impegnati a dimostrarne l’inevitabilità o, addirittura,
l’utilità e a ridimensionarne la pericolosità.
Il rischio dell’assuefazione
La cosa che preoccupa di più è la percezione molto bassa che si ha
nell’opinione pubblica della pericolosità di questa deriva dell’economia
capitalistica, in atto da decenni. Due fattori principali,
probabilmente, vi contribuiscono. Da un lato, l’esaltazione del successo
economico e della ricchezza che ne deriva che si è installata, a tutti i
livelli, nella cultura di massa. Dall’altro, l’assuefazione a una sorta
di intangibilità dei processi capitalistici, considerati alla stregua
di eventi naturali cui è impossibile opporsi perché radicati nella
natura delle cose. Fa da sfondo a questo clima culturale la sfiducia
strisciante e sempre più diffusa nella possibilità di utilizzare
efficacemente lo strumento della democrazia per contrastare e
controllare la concentrazione del potere economico. La democrazia
dovrebbe essere considerata un bene comune, ma, come spesso avviene per i
beni comuni, quando si offusca o si perde il senso del vivere insieme,
il bene comune si trasforma più o meno rapidamente nel bene di nessuno. È
lì, a disposizione, e viene utilizzato, ma nessuno se ne prende cura,
nella fiducia assolutamente irrazionale che resterà eternamente a
disposizione. I beni comuni, invece, se non accuditi, rispettati,
coltivati da tutti i cittadini, deperiscono e alla fine scompaiono. Non
ci sono più, bisogna farne a meno. Solo allora, eventualmente, si
avverte che c’è stata una perdita, perché la qualità della vita è
peggiorata e non si riesce a capire perché. Questa è, oggi la condizione
della democrazia. Ce n’è quel tanto che serve per non doversi occupare
di creare alternative. Fornisce prestazioni mediocri, spesso
insoddisfacenti, accrescendo l’indifferenza, se non l’insofferenza, per
la dimensione collettiva, per tutto ciò che è pubblico, di tutti.
Il compromesso keynesiano
C’è stato un momento in cui il “secolo breve” ha deviato dalla sua
traiettoria e si è proiettato su di un terreno sconosciuto, alla ricerca
dei modi in cui domare il capitalismo oligopolistico delle grandi
imprese che si ergeva come una minaccia mortale nei confronti della
democrazia. Dopo il disastroso esperimento della Repubblica di Weimar,
segnata dall’ingerenza dei grandi monopoli tedeschi, dopo le disastrose
conseguenze della Grande crisi, di fronte all’insorgere del
nazionalsocialismo e del fascismo, forte e impellente era la necessità
di ragionare su di una via di uscita che non lasciasse il destino della
democrazia nelle mani dei monopoli. Negli Stati Uniti venne il momento
del New Deal di Franklin D. Roosevelt, con il suo impeto e il
suo radicalismo innovatore. In Germania, con maggiori rischi e più
sommessamente, un gruppo ristretto di persone, riunito a Friburgo, si
mise all’opera per provare a immaginare un nuovo ordine economico e
politico, una volta che il nazismo fosse stato sconfitto. I nomi degli
artefici di quei tentativi sono oggi sconosciuti ai più: Henry Simons e
Thurman Arnold negli USA, Walter Eucken e Franz Böhm in Germania, ma il
loro lavoro è stato e rimane l’unico tentativo serio di affrontare il
problema del potere economico in una società democratica. La
formulazione più chiara, incisiva e anche drammatica del problema è
quella consegnata a un messaggio del Presidente Roosevelt al Congresso
del 29 aprile 1938. Essa ha al centro “due verità semplici sulla libertà
di un popolo democratico. La prima verità è che la libertà di una
democrazia non è al sicuro se il popolo tollera la crescita del potere
privato fino al punto in cui esso diventa più forte dello stesso stato
democratico… La seconda verità è che la libertà di una democrazia non è
al sicuro se il sistema economico non fornisce occupazione e non produce
e distribuisce beni in modo da sostenere un livello di vita
accettabile” (Franklin D. Roosevelt, Message to Congress on the Concentration of Economic Power,
April 29, 1938). Il problema, secondo Roosevelt, è che “oggi sta
crescendo una concentrazione del potere privato che non ha uguali nella
storia. Questa concentrazione sta compromettendo seriamente l’efficienza
economica dell’impresa privata quale strumento per dare occupazione al
lavoro e al capitale e quale strumento per assicurare una distribuzione
più equa del reddito e dei guadagni fra le persone della nazione nel suo
insieme” (ibid.).
Tutti i personaggi citati ritenevano che una concentrazione del
potere economico tale da limitare o cancellare la concorrenza fosse
incompatibile con un regime democratico e, più o meno apertamente, erano
a favore di regole che ne prevedessero e imponessero la dissoluzione.
Non si trattava, anche allora, di controllare gli abusi di quel potere,
ma di eliminarne i presupposti. “Non sono da combattere i cosiddetti
abusi del potere economico – sosteneva Eucken – ma il potere economico
in quanto tale”.
Quei tentativi, per quanto lucidi e generosi, sono falliti. Hanno
prodotto qualche temporanea correzione, hanno costretto il capitalismo
oligopolistico a qualche momentanea concessione sulla cui scia si è
riusciti, per un trentennio o giù di lì, a far vivere un compromesso nel
nome del keynesismo. Ma il problema non è stato risolto, anzi, nel
corso del ventennio della Grande moderazione, fra il 1987 e il 2007, si è
aggravato fino a esplodere con la globalizzazione. L’intera parabola
della Crisi finanziaria globale, dai processi che ne costituiscono il
presupposto a quelli che ne costituiscono le conseguenze, mostra con
tutta evidenza che essa si è prodotta nel segno dell’oligarchia
finanziaria e delle imprese too big to fail, che l’ha, di
fatto, imposta con i propri comportamenti, cui nessun governo, nessun
potere politico, è stato in grado di opporsi. Il potere economico delle
grandi istituzioni finanziarie si è mosso indisturbato, nel
perseguimento dei propri obbiettivi, finché la realtà non si è
ribellata. Il medesimo potere incontrollato, nel momento della crisi, ha
imposto a noi tutti di pagare i conti del disastro che esso, è solo
esso, aveva prodotto.
Un nuovo compromesso
Nella misura in cui il potere economico soppianta e soggioga il
potere politico, viene meno la capacità del sistema politico di operare
per garantire le condizioni della coesione sociale tramite il patto
fiscale che è alla base di ogni sistema di governo. Se le politiche
governative, sociali ed economiche, sono decise dell’oligarchia
finanziaria, è assai improbabile che contengano quelle azioni di
ridistribuzione del reddito che sono necessarie per compensare le
disuguaglianze che sono il prodotto necessario dello sviluppo
capitalistico. Vi è oggi un trade off irriducibile fra la permanenza del
potere economico ai livelli raggiunti e l’ordinato funzionamento di una
società democratica. Tertium non datur. Occorre scegliere.
Occorre porre le basi di un nuovo compromesso che prenda il posto di
quello, ormai svuotato e inadeguato, che va sotto il nome di Keynes.
Il presupposto di questo nuovo compromesso è lo smantellamento del
potere economico nelle forme e nelle dimensioni che oggi conosciamo.
Un’esperienza ormai secolare ci mostra che non c’è alcuna possibilità di
domare il potere economico una volta che si sia installato all’interno
di un sistema sociale. Ci si può tutelare dagli effetti perniciosi che
ne derivano solo impedendo che si formi. Gli ordinamenti giuridici
devono portare al proprio interno norme atte a impedire la formazione di
un potere economico esorbitante. Non è semplice. E non lo è proprio per
lo svuotamento delle dinamiche democratiche che è causa ed effetto
della situazione in cui ci troviamo. È un circolo vizioso che solo una
forte ed ampia mobilitazione dell’opinione pubblica potrebbe spezzare.
Prima che un qualche disastro sociale ce lo imponga.
Alla ricerca del cambiamento che verrà
I cambiamenti rilevanti, in un sistema sociale, non sono quasi mai il
frutto univoco di decisioni chiare e condivise assunte da qualcuno che è
in grado di attuarle. Sono piuttosto il prodotto congiunto di una
pluralità di decisioni e di scelte, e anche di non decisioni, di
astensioni, che interagiscono fra di loro in modi che nessuno è in grado
di prevedere e, tanto meno, controllare. Spesso tali cambiamenti
prendono forma senza che nemmeno ce ne accorgiamo.
L’osservatore
delle dinamiche sociali, dunque, se è intellettualmente onesto e
consapevole, si astiene dal “prescrivere ricette… per l’osteria
dell’avvenire” (Marx 1873) e si sforza piuttosto di individuare i
fenomeni principali che sono suscettibili di combinarsi dando luogo a un
cambiamento sociale di rilevanza sistemica. Oggi, di fronte al
profluvio di ricette da cui siamo sommersi e confusi, è difficile tenere
questa rigorosa linea di condotta, anche perché non è facile ritrovare
un filo del cambiamento che da troppo tempo abbiamo perso, sedotti o
sopraffatti da dottrine che avevano l’unico scopo di disarmarci
intellettualmente.
Per tornare al nostro tema, il destino della democrazia, non vedo,
allo stato delle cose, dinamiche emergenti, o anche consolidate, che
possano far pensare a una riapertura dei processi di democratizzazione
della vita sociale. La democrazia sostanziale appare destinata, per un
periodo non breve, a restare inscritta nella sfera dell’utopia. C’è solo
da sperare che la democrazia formale, l’unica che oggi possediamo, non
degeneri ulteriormente, facendo avanzare sempre più il potere delle
oligarchie.
L’offuscamento delle appartenenze di classe, che è il risultato del
superamento del fordismo, ha fatto emergere una società indistinta, la
società del 99%, dal potenziale enorme e dal potere nullo. Potenziale
enorme, perché virtualmente in grado di delineare e praticare un nuovo
ordine sociale; ma potere nullo, perché il 99% non riesce a darsi
strumenti di azione politica che efficacemente la rappresentino, al di
là dei tenui ed evanescenti legami istituiti dai network su internet.
Non riesce a esprimere una cultura, tanto meno un programma politico,
un’idea di società. Riesce solo e riconoscersi nella propria
subalternità. L’impotenza del 99%, a sua volta, esalta e moltiplica il
potere delle élite che, al contrario, possiedono efficacissimi e
potentissimi strumenti di azione, primo fra tutti il potere economico
che esercitano quasi indisturbate dai vincoli leggeri della democrazia
formale.
Non dobbiamo farci illusioni. Oggi, più che mai, il potere di
influire sui processi che disegnano l’ambiente economico e sociale,
nonché politico, in cui viviamo è nelle mani di una ristrettissima élite
globale che è totalmente impermeabile alle richieste e alle esigenze
del 99%. Priva di qualsiasi cultura politica, semplicemente perché non
ne ha bisogno, opera e decide nell’unica prospettiva di mantenere e
accrescere il proprio potere e la propria ricchezza, convinta che
“l’intendenza seguirà”. È la prospettiva plasticamente rappresentata
dalla teoria economica del “trickle down”, non a caso impostasi nell’era
della Grande moderazione, in cui si è formata l’attuale élite globale
del potere. Quello che conta è che i ricchi continuino ad arricchirsi:
qualcosa, alla fine, “gocciolerà giù” per consentire al 99% di
sopravvivere. E basta così. Nessuno si ribellerà.
Conclusione pessimistica, quasi disperata. Il panorama che abbiamo
davanti non consente visuali diverse. I venti di guerra che soffiano per
ora a folate, la minaccia terribile di un ritorno delle guerre di
religione, le più crudeli e sanguinose contribuiscono a rendere il
quadro ancora più oscuro. Non dobbiamo perdere di vista, tuttavia,
alcune linee di faglia che attraversano la società globale, partendo
dalle scandalose disuguaglianze di reddito e di ricchezza, che un
capitalismo senza freni e lo svuotamento della vita democratica hanno
certamente favorito. La storia suggerisce che le disuguaglianze estreme
sono fonte pressoché certa di reazioni. Si tratterà di vedere se dentro o
fuori dal perimetro democratico.