
Negli ultimi trent’anni abbiamo assistito, in materia fiscale, ad una tendenza univoca molto chiara: lo spostamento del carico fiscale dai più ricchi ai più poveri
e dai redditi di capitale ai redditi da lavoro. Questa tendenza è stata
accompagnata da una sempre più sofisticata capacità di evasione ed
elusione fiscale da parte dei redditi da capitale, in particolare i
grandi capitali che possono essere esportati, legalmente o illegalmente,
all’estero. In estrema sintesi: i lavoratori e i soggetti meno abbienti
pagano sempre più imposte, i capitali e i soggetti più ricchi ne pagano
sempre meno. Un dibattito politico ed economico fortemente impoverito,
tuttavia, colpevolmente ignora questi aspetti: ad essere oppressi dal
carico fiscale sarebbero esclusivamente solerti imprenditori,
scoraggiati dal “fare impresa” e generare ricchezza per tutti da uno
Stato oppressore e sanguisuga.
Proviamo a fare chiarezza ed un po’ di
pulizia. Tra i temi più evocati nel dibattito politico e giornalistico
di questi giorni un posto d’onore spetta senza dubbio all’IVA, l’imposta
sul valore aggiunto. Se ne paventa un aumento a decorrere dal 2019 e i
partiti politici si affannano a capire come poter scongiurare questo
evento, previsto dalla clausola di salvaguardia
presente nella legge di bilancio dall’ormai lontano luglio 2011.
Secondo tale clausola, l’aumento dell’IVA scatta automaticamente nel
momento in cui non si sono raggiunti gli obiettivi di contenimento del
deficit previsti dalla Commissione europea. Ma procediamo per gradi.
Il carico fiscale, in generale, è quella
quota del reddito nazionale di cui lo Stato si appropria attraverso
tributi di vario genere. La percezione comune e la trattazione mediatica
dell’argomento inducono a pensare che le imposte siano tutte uguali. La
confusione è aumentata dal fatto che spesso si paventa l’aumento delle
imposte, senza ulteriori qualificazioni, o se ne rivendica la loro
riduzione in generale. Questo, però, offre un’immagine distorta. Se si
adotta questa chiave di lettura, sembrano emergere solamente due
posizioni possibili in tema fiscale: chi è a favore di più imposte per
tutti e chi invece ne vuole di meno, per tutti. Così facendo, però, si
perde completamente di vista l’impatto che la tassazione può avere sulla
distribuzione del reddito: le imposte sono profondamente diverse,
perché ciascuna di esse colpisce in maniera proporzionalmente diversa,
più o meno accentuata, un segmento diverso della popolazione.
Per quanto riguarda l’IVA, quest’ultima
gioca un ruolo dominante nella determinazione del carico tributario
indiretto. Prima di spiegarne il significato specifico è opportuno
richiamare brevemente la differenza tra un’imposta diretta e indiretta.
Un’imposta diretta colpisce direttamente
la capacità contributiva del soggetto in questione. Ovvero l’individuo
paga l’imposta sulla base delle sue entrate effettive e quindi della sua
capacità personale di contribuire alle entrate dello Stato e al
finanziamento della spesa pubblica. Per questo motivo l’imposta diretta
colpisce il reddito, o al limite il patrimonio, in quanto si tratta di
immediati indicatori del benessere dell’individuo e della sua
possibilità di contribuire ai bisogni della collettività.
Un’imposta indiretta, invece, colpisce
una manifestazione mediata di capacità contributiva degli individui.
L’esempio più tipico sono i consumi. Vediamo meglio cosa implica
un’imposta sui consumi con un banale esempio. Il signor X consuma un
caffè il cui prezzo, al netto delle imposte, è pari a 1 euro. Il bene di
consumo caffè, tuttavia, è gravato di un’imposta del 20%, cosicché il
prezzo finale diviene 1,20 euro. Il consumatore nel momento
dell’acquisto del caffè sta pagando una percentuale del suo prezzo, 20
centesimi, allo Stato. Viene quindi colpito dall’imposta non sulla base
del suo livello di benessere economico, reddito o ricchezza, ma solo in
quanto sta consumando un bene. Su quello stesso caffè, chiunque, anche
un soggetto che ha un reddito di 100 volte superiore a quello del primo
soggetto, pagherà sempre e comunque 20 centesimi di imposta. Un’imposta
indiretta, insomma, non tiene conto in alcun modo della situazione
economica del contribuente e colpisce a pioggia tutti, ricchi e poveri,
alla stessa maniera. Come dicevamo, le imposte non sono tutte uguali.
L’IVA è meno uguale delle altre.
In tempi di austerità, la ricetta imposta
dalla Commissione europea a tutti i paesi membri è sempre la solita:
riduzione del debito e del deficit da praticare tramite il conseguimento
di avanzi primari di bilancio. Le entrate dello Stato devono eccedere
le uscite per poter così drenare risorse per ridurre il debito e allo
stesso tempo non creare nuovi deficit annuali. In concreto questo
significa taglio della spesa e aumento delle imposte, con conseguenze
restrittive sulla domanda e recessive sul prodotto nazionale.
L’austerità, tuttavia, non ha solamente
finalità recessive. Ha anche una chiara direzione redistributiva
immediata, che si manifesta a seconda di dove lo Stato decide di far
ricadere l’onere degli aggiustamenti di finanza pubblica. Non
sorprendentemente, l’austerità è stata consistentemente declinata in
maniera tale da colpire in maniera sproporzionata il mondo del lavoro e
le fasce di reddito più basse. Per i governi che applicano l’austerità,
non è evidentemente sufficiente disciplinare la forza lavoro creando
disoccupazione.
Non è insomma un caso se tutti i governi
degli ultimi anni hanno contribuito a ridurre le imposte sui più ricchi e
allo stesso tempo a spostare in modo graduale il carico dalle imposte
dirette a quelle indirette. Tra queste ultime il primo imputato è
proprio l’IVA. Nel corso degli ultimi trent’anni, a fronte di una
riduzione progressiva delle aliquote IRPEF gravanti sui redditi più
elevati e di una riduzione delle imposte sui redditi delle società di
capitale (IRES), si è invece assistito ad un progressivo e inesorabile
aumento dell’imposta sui consumi.
I due grafici che seguono mostrano
inequivocabilmente quanto accaduto dagli anni ’80 in poi. Si riportano
l’aumento dell’aliquota percentuale IVA dal 1973, quando ammontava al
12%, ad oggi e fino al previsto aumento al 25% nel 2021. Subito sotto si
riporta invece il calo continuo dell’aliquota superiore IRPEF, che
colpisce i redditi più elevati, scesa nello stesso lasso temporale dal
72% al 43% (senza tenere conto peraltro della drastica riduzione della
distanza tra le fasce di reddito colpite dalle diverse aliquote).
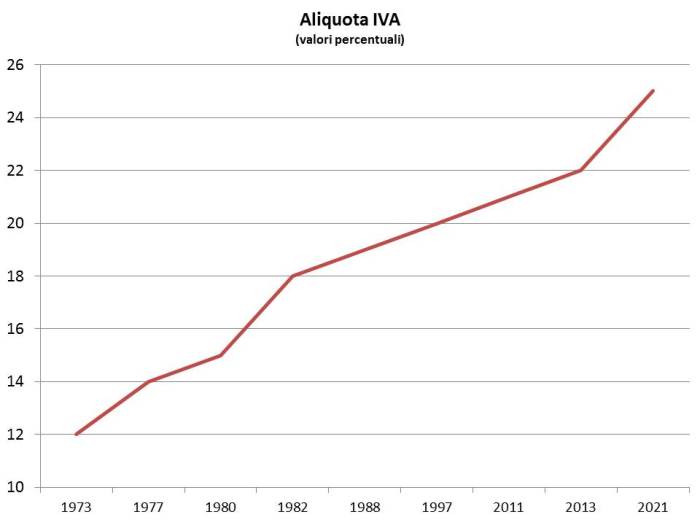

Le imposte indirette, e tra queste l’IVA,
negano a priori la possibilità di praticare il precetto costituzionale
della progressività (art. 53 Cost.) in quanto, come dimostrato, ricadono
a pioggia sull’intera platea dei contribuenti, indipendentemente dalla
loro capacità contributiva. Ma c’è di più. È facile dimostrare che l’IVA
non solo è palesemente non progressiva ma è persino manifestamente regressiva,
ovvero colpisce i poveri in maniera maggiore dei ricchi, ovvero sottrae
ai più poveri una percentuale di reddito maggiore di quella sottratta
ai più ricchi. Il motivo è semplicissimo. Un soggetto che ha un reddito
basso ne consuma per definizione una percentuale elevatissima. Dovrà
infatti soddisfare i suoi bisogni primari e non avrà risorse aggiuntive,
se non esigue, per alimentare i suoi risparmi. Al contrario, un
soggetto abbiente avrà una propensione percentuale al consumo molto più
bassa poiché una volta soddisfatti numerosi bisogni, dai più essenziali
ai più superflui, continuerà ad avere soldi che deciderà di risparmiare.
E così il più povero vedrà una quota consistente, prossima alla
totalità del proprio reddito per i molto poveri, tassata dall’IVA, il
più ricco invece solo la quota parte destinata ai consumi, mentre ciò
che risparmia sarà esente da quell’imposta.
Ecco svelato il mistero dell’accanimento
da parte dei commissari dell’austerità liberista sulla necessità di
continui aumenti dell’IVA in tutti i paesi europei e in particolare in
quelli maggiormente soggetti alla pressione di Bruxelles.
Torniamo all’Italia. Nel 2011 il governo
Berlusconi, messo alle strette dalla Commissione europea, inserì nella
legge di bilancio una clausola di salvaguardia, tale per cui il non
conseguimento degli obiettivi sulla riduzione del deficit annuo avrebbe
automaticamente fatto scattare aumenti progressivi dell’IVA. E così dal
20% l’IVA è scattata al 21% a gennaio 2013 e poi al 22% a ottobre dello
stesso anno. Gli aumenti successivi sono stati congelati per quattro
anni. Ma adesso la clausola è pronta a scattare. I nuovi aumenti
previsti porterebbero l’IVA al 24,2% nel 2019 e al 25% nel 2021.
Aumenterebbe anche l’aliquota per particolari tipi di beni di carattere
artistico e culturale o legati a incentivi al risparmio energetico, che
dal 10% passerebbe al 13% nel 2021. Incrementi fortissimi,
in tempi molto ristretti, che non potranno che avere evidenti effetti
regressivi sulla distribuzione del reddito e recessivi nel causare un
calo dei consumi.
L’idea di dare luogo a massicci travasi
di gettito dalle imposte dirette a quelle indirette è del resto un punto
programmatico essenziale della visione liberista dell’economia, secondo
cui le imposte dirette altererebbero le scelte dell’agente economico,
disincentivando lavoro e investimenti e penalizzando la buona attitudine
del ricco al risparmio virtuoso; mentre quelle indirette, se estese a
tutti i beni e servizi, non sarebbero distorsive. Non è un caso che i
più accaniti sostenitori dell’austerità liberista abbiano ufficialmente
difeso un riequilibrio delle entrate dall’imposta sul reddito a quella
sui consumi. Lo espresse a chiare lettere il governo Monti e ne ha fatto una bandiera programmatica il partito +Europa di Emma Bonino.
Proprio in questi giorni si discute di
come poter bloccare l’operatività delle clausole di salvaguardia. Dentro
la cornice dei vincoli europei attuali, cui l’Italia è volutamente
legata mani e piedi, l’unica soluzione sarebbe recuperare altrove il
gettito garantito dall’aumento dell’IVA. Si tratta di cifre consistenti:
12,5 miliardi per il 2019 e 20 miliardi nel 2020.
L’Unione Europea ha di fatto fissato un
aut-aut dal sapore squisitamente liberista e austero: o si aumenta l’IVA
o si tagliano le spese, che significa taglio alla spesa sociale in
prima battuta. La barzelletta del taglio dei cosiddetti sprechi, oltre a
non cambiare nulla in merito al significato recessivo delle
prescrizioni di bilancio, viene usata come specchietto per le allodole
per camuffare dosi da cavallo di tagli a pioggia alle componenti di
spesa sociale più aggredibili, come avviene ininterrottamente da ormai
molti anni (dalla sanità all’istruzione alle pensioni).
Le forze politiche oggi sull’arena
discutono su come dimenarsi tra il taglio della spesa sociale e
l’aumento di una delle imposte più inique del sistema fiscale italiano.
Misure entrambe fortemente recessive, che comporterebbero un ulteriore
calo della domanda e del prodotto, e gravemente inique, che andrebbero a
palese detrimento delle classi subalterne.
La soluzione, a ben vedere, è molto più
semplice anche se politicamente più impegnativa: rifiutare l’alternativa
tra la padella e la brace e respingere i diktat sul pareggio di
bilancio che stanno asfissiando le economie europee e incrementando
disoccupazione, miseria e disuguaglianza.

Nessun commento:
Posta un commento