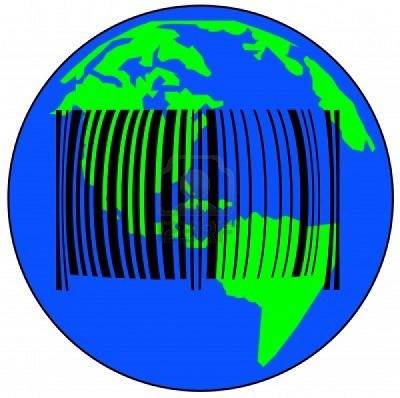 Inutile
nasconderselo: la questione del protezionismo (in particolare nei
confronti del sud del mondo) ha sempre posto problemi formidabili alle
forze progressiste in Europa, e anche agli uomini e alle donne di buona
volontà. A mettersi dal punto di vista degli interessi immediati delle
classi popolari, il dilemma è evidente: il protezionismo protegge il
lavoro di quelli che lo hanno, ma, garantendo un monopolio ai
produttori nazionali, privano le famiglie con il reddito più basso di
beni a cui potrebbero avere accesso. Il protezionismo è la vita più
cara, e questo è spesso il motivo per il crollo delle politiche
protezionistiche, sotto la pressione di chi faceva balenare l’accesso a
merci a basso costo. Marx ha combattuto contro la politica
protezionistica dei Tories e sostenuto il liberoscambismo dei Whigs, che
sostenevano l’apertura del mercato britannico al frumento prussiano o
russo. Se si aggiungono considerazioni di solidarietà con lo sviluppo
del Sud del Mondo, è difficile fare le barricate contro i prodotti dei
paesi meno ricchi, che non hanno altri vantaggi da offrire se non
precisamente i loro bassi salari. Ma a questo arriva ad opporsi oggi un
nuovo argomento: quello dell’ecologia. Tutti i trasporti implicano
energia e quindi inquinamento, effetto serra …
Inutile
nasconderselo: la questione del protezionismo (in particolare nei
confronti del sud del mondo) ha sempre posto problemi formidabili alle
forze progressiste in Europa, e anche agli uomini e alle donne di buona
volontà. A mettersi dal punto di vista degli interessi immediati delle
classi popolari, il dilemma è evidente: il protezionismo protegge il
lavoro di quelli che lo hanno, ma, garantendo un monopolio ai
produttori nazionali, privano le famiglie con il reddito più basso di
beni a cui potrebbero avere accesso. Il protezionismo è la vita più
cara, e questo è spesso il motivo per il crollo delle politiche
protezionistiche, sotto la pressione di chi faceva balenare l’accesso a
merci a basso costo. Marx ha combattuto contro la politica
protezionistica dei Tories e sostenuto il liberoscambismo dei Whigs, che
sostenevano l’apertura del mercato britannico al frumento prussiano o
russo. Se si aggiungono considerazioni di solidarietà con lo sviluppo
del Sud del Mondo, è difficile fare le barricate contro i prodotti dei
paesi meno ricchi, che non hanno altri vantaggi da offrire se non
precisamente i loro bassi salari. Ma a questo arriva ad opporsi oggi un
nuovo argomento: quello dell’ecologia. Tutti i trasporti implicano
energia e quindi inquinamento, effetto serra …La resistenza “di sinistra” al protezionismo
Dopo 30 anni di un modello liberal-produttivista ormai in crisi, i
discorsi a favore della demondializzazione e per la rilocalizzazione
sembrano sbattere contro il buon senso e la giustizia.
Eppure è sufficiente evocare l’idea di un rincaro delle merci
importate (sia sotto forma di eco-tasse supplementari sul carburante o
di un’Iva sociale) perché subito voci si levino a sinistra “Questo non
farà che aumentare il costo della vita per i più poveri!”. Prova che il
dibattito non ha fatto molti progressi.
No, il dibattito non è andato molto avanti, ed è anche diventato non
solubile in questa forma. Le soluzioni sembrano chiuse da tutti i lati.
Se prendiamo il caso dei prodotti “complementari” venuti dall’estero,
vale a dire i prodotti che non potremmo produrre noi stessi, come il
petrolio, la loro “necessità” sembra imporre, in nome della lotta per il
potere di acquisto, le minori tasse possibili. E ogni rincaro per
volontà politica (aumento delle tasse sui prodotti petroliferi o una
“carbon tax“) sembrerà un attacco contro gli interessi popolari,
nonostante l’evidente vantaggio ecologico.
Se si guarda ai prodotti “sostitutivi”, vale a dire quelli che
potrebbero essere sostituiti da una produzione locale alternativa,
l’argomento della difesa dell’occupazione è anch’esso rapidamente
spazzato via dall’argomento dei costi. Il bel libro di Florence Aubenas,
“Le quai de Ouistreham”, mostra che fin negli strati più precari del
lavoro salariato francese, l’uso del computer e di Internet è entrato
nella normalità del consumo. Ora, è improbabile che le donne delle
pulizia che puliscono i ferry boat avrebbero avuto accesso al computer,
se esso fosse stato prodotto dalla fabbrica Thomson di Angers. E’ stata
proprio la globalizzazione, con il trasferimento massiccio
dell’industria manifatturiera “leggera” verso il vecchio “terzo mondo” a
permettere l’accesso massiccio dei lavoratori precari francesi a
prodotti che essi difficilmente avrebbero potuto produrre da sé a prezzi
abbordabili, ivi compresi i loro abiti.
Tuttavia, bisogna guardare le cose da un punto di vista più storico.
Quando, nei primi anni ottanta, la Francia era ancora un’industria
dell’elettronica di consumo, ha in effetti iniziato a produrre computer
nazionali (il TO7, ecc.). E se vi ha rinunciato, è a causa di una serie
di errori industriali, ma soprattutto perché è stata coinvolta nello
svilupparsi di una nuova divisione internazionale del lavoro, nel quadro
del nuovo modello liberal-produttivista. Che ha rovesciato
completamente il dibattito sul protezionismo, cambiando la natura stessa
della divisione internazionale del lavoro.
Circuiti produttivi globalizzati
In altri tempi (prima degli anni ottanta) le cose erano abbastanza
semplici. Il Nord, industrialmente dominante, produceva, in modo
autosufficiente, i suoi beni manifatturieri e li esportava nel terzo
mondo. Questi, penalizzato da una arretratezza tecnologica ereditata
dalla colonizzazione, non riusciva a produrre per il mercato mondiale
dei beni manifatturieri ed doveva importarli in cambio di materie prime
agricole o industriali. La “complementarità” era inscritta in questa
prima divisione internazionale del lavoro, che risaliva alle origini del
capitalismo industriale. I paesi del terzo mondo decisi a uscire da
questo destino dovevano imporre a se stessi il protezionismo sulle loro
“industrie nascenti”, per sostituire, alle importazioni, una produzione
locale protetta da barriere doganali.
La posizione delle forze progressiste occidentali consisteva allora
nell’incoraggiare questi modelli di sviluppo di questo tipo (sostenuti
dalle sinistre sudamericane negli anni cinquanta e sessanta). Noi quindi
eravamo protezionisti a favore del terzo mondo, ma sostenitori
dell’aprire generosamente i nostri mercati alle prime produzioni
industriali del mondo in via di sviluppo. Non correvamo un grande
rischio, perché in realtà essi offrivano allora solo la prima delle
industrie manifatturiere, il tessile… E, grazie all’accordo multifibre
elaborato nell’ambito dell’aAccordoo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio (Gatt), i capitalisti occidentali, feroci difensori del
libero scambio verso il terzo mondo, si erano protetti dalle
importazioni dal terzo mondo con il pretesto di difendere i posti di
lavoro tessili nordamericani o europei.
Tutto cambia discretamente negli anni settanta. Gli stessi
industriali occidentali, fino a quel momento protezionisti sui prodotti
fabbricati nel terzo mondo, cominciano a rendersi conto del vantaggio
che avrebbero a produrre in questi paesi a bassi salari. Parallelamente,
delle élites, in alcuni di questi paesi del terzo mondo, si rendono
conto che le politiche di sostituzione delle importazioni offrono loro
solo minuscoli mercati interni, e avevano tutto l’interesse ad
associarsi a questa nuova strategia industriale: accettare le fabbriche
del Nord e re-importare verso di esso i beni prodotti in casa a costi
molto bassi. Quaranta anni dopo, questi ex “Stati fabbriche” hanno messo
radici nell’insieme del pianeta (con l’eccezione di gran parte
dell’Africa), e una nuova divisione internazionale del lavoro si è
stabilita, con il Nord che si occupa solo solo dell’alta tecnologia e
delle attività di progettazione, e il Sud a cui viene assegnata la
produzione.
Non dobbiamo illuderci: nei paesi del Sud in cui le classi dominanti
sono più dinamiche, l’appropriazione delle filiere tecnologiche verso
la gestione di prodotti sempre più qualificati è ormai irreversibile.
Né la Corea del Sud, né la Cina sono le basi di outsourcing,
ma in tutto e per tutto dei nuovi concorrenti. E la storia
multisecolare della Cina dimostra che essa non fa che riprendere il
posto che è stato suo per la maggior parte della storia del mondo:
l’Impero di Mezzo, culla delle grandi invenzioni.
Pertanto, la “complementarità” nel commercio internazionale ha
cambiato natura. Le nazioni, o piuttosto le zone socialmente
differenziate del pianeta, non scambiano più tra loro prodotti di
diversi settori. Scambiano, all’interno di ogni settore, prodotti di
livello tecnologico e che richiedono una forza lavoro di diversa
qualificazione. La tecnica di superficie del molo di Ouistreham non può
più acquistare il suo computer alla fabbrica Thomson di Angers.
Potrebbe acquistare in Europa chip specializzati, macchine per stampare
questi chip o tagliarli con il laser, ma non ne ha l’uso, né i mezzi. E
la conseguenza più tragica è che, certo, i suoi colleghi operai
dell’Ovest francese degli anni settanta, dalla Thomson di Angers alle
fabbriche Moulinex in Bassa Normandia, sono rimasti senza lavoro.
A questo conseguenza sociale principale – la disoccupazione di massa
dei lavoratori poco qualificati in Europa occidentale – se n’è
gradualmente aggiunta un’altra: la frammentazione indefinita del
processo di produzione di tutti i settori produttivi, terziari e
agricoli compresi, in segmenti sempre più brevi distribuiti dalle
multinazionali sull’insieme del pianeta, in base a un calcolo sul costo
del lavoro, della fiscalità e delle norme ambientali più o meno
vantaggiose, e di vicinanza ai mercati emergenti. Da qui una esplosione,
senza rapporto con l’espansione della produzioen reale, del trasporto
merci. E non più sotto forma di trasporto di merci in massa (come i
vecchi treni merci), ma una miriade di micro-trasporti a flusso
continuo, con container, per via aerea, su camion… con l’enorme spreco
di energia e la produzione insostenibile di emissioni di gas a effetto
serra che lo accompagnano.
Questa è la la geografia del modello economico che si è sviluppato
dagli anni ottanta: il liberal-produttivismo. Un modello che ha generato
una straordinaria espansione del lavoro salariato, ma dall’altra parte
del mondo, in Cina, India, Vietnam, Malesia, Thailandia .. Un modello
che ha notevolmente aumentato il potere d’acquisto di coloro che
avevano un reddito, per abbigliamento, piccoli elettrodomestici ed
elettronica, ma privando dell’occupazione, e quindi dei mezzi per
acquistare questi prodotti, una parte dei salariati occidentali. Da qui
il clamore che si alza oggi, di fronte alla crisi, per una
“de-mondializzazione” o una “rilocalizzazione”.
Ma è subito evidente che il problema non può essere risolto con
semplici decreti protezionisti a livello nazionale: questo protezionismo
paralizzerebbe delle filiere impossibili da ricostruire a breve
termine su base locale, immediatamente priverebbe gli strati più poveri
tra i salariati occidentale la maggior parte dei prodotti che ancora
forniscono loro un benessere precario, condannando allo stesso tempo
alla disoccupazione settori interi delle industrie emergenti nel Su del
Mondo. E allora che fare?
La gran parte dell’attività rimarrà locale
Constatiamo innanzitutto che il quadro non è così manicheo. Ciò che
consumiamo oggi non è sempre arrivato dai circuiti di filiere
frammentate attraverso il pianeta; le produzioni in questo o quel paese
non sono tutte rigidamente complementari di produzioni provenienti da
altri paesi, in ogni caso non nel medio termine .
Prima scappatoia nei fatti: l’attività umana è delocalizzabile solo
in modo parziale. Gli studi statistici condotti negli anni settanta
(quando la “nuova globalizzazione” era solo agli inizi) mostravano che
l’80 per cento del lavoro umano che noi consumiamo nelle nostre vite è
prodotto in un raggio di meno di 20 km da casa. Le cifre non sono molto
cambiate oggi. In effetti, abbiamo consumiamo ancora principalmente: il
prodotto della niostra attività domestica, poi di costruzioni o di
lavori pubblici, inoltre quantità indefinitamente crescenti di servizi
alla persona, si tratti di servizi pubblici (istruzione, salute, cultura
e tempo libero, cura della persona) o di servizi commerciali (come
appunto il servizio di pulizia del Quai de Ouistreham).
Resta d’altra parte un margine di sostituzione importante tra le
merci trasferibili da un paese all’altro e i servizi alla persona,
prodotti e offerti a livello locale. Questo è evidente nel caso della
manutenzione e del tempo libero, lo è a maggiore ragione nel caso dei
servizi alla persona. Enormi riserve di posti di lavoro aspettano solo
di fiorire nei servizi alla comunità, sotto forma di economia sociale e
solidale. Ma, anche restando ai prodotti manifatturieri, vi è un arco
importante disostituzioni tra, ad esempio, l’importazione di automobili e
la produzione locale di servizi di trasporto: costruzione di autobus,
tram, metropolitane e treni (così pesanti da trasportare che devono
essere prodotto nello stesso continente), creazione di siti puliti,
manutenzione dei morori. Allo stesso modo, noi non spaventiamoci per il
dominio cinese sulla produzione di cellule fotovoltaiche: la maggior
parte del lavoro consiste nell’assemblaggio e nell’installazione di
questi pannelli sul tetto dei nostri edifici…
Ridurre la dipendenza di una regione dalle importazioni, significa
prima di tutto aumentare la quota di attività dedicata al servizio alla
comunità, diminuire il consumo di macchine inquinanti e aumentare la
produzione di servizi locali (pubblici o privati) che riducano
l’inquinamento. Non si tratta di protezionismo alle frontiere: è una
questione di scelta di un modello di consumo. Inoltre, la
“rilocalizzazione” richiesta dagli ambientalisti ignora il tracciato
delle frontiere e si preoccupa solo delle distanze, misurate in
tonnellate di CO2 emesse per tonnellata di merci spostata.
Proteggere il mercato interno o proteggere le relazioni sociali?
Guardiamo poi, ma solo poi, alla sostituzione tra importazioni e
produzione nazionale degli stessi prodotti. Quel che la globalizzazione
ha sconfitto dopo gli anni ottanta (il carattere relativamente
autocentrato delle economie nord-occidentali), gli anni dieci lo possono
ricucire: ed è qui che intervengono le questioni di politica
industriale e di protezionismo. E’ del tutto possibile riparare
progressivamente un tessuto industriale quando la sua disintegrazione è
solo il risultato di scelte opportuniste, fondate sulle differenze di
retribuzione, di fiscalità, di tutela dell’ambiente, e sul prezzo basso
dell’energia, quindi dei trasporti.
Notiamo subito che questo progetto non ha nulla a che fare con il
protezionismo di destra dei governi liberali degli anni trenta (Hoover,
Ramsay McDonald-Snowden, Tardieu-Laval …) o con quello dei paesi
fascisti o dell’Unione sovietica. Quel protezionismo partiva dall’idea
che esistesse un mercato nazionale sufficiente per la produzione
nazionale. Ci si accorse rapidamente che questo protezionismo aggravava
la crisi: in un mercato nazionale che già si contraeva per motivi
interni, si aggiungeva la sparizione dei mercati esteri. Difendere oggi
il protezionismo in nome della stessa argomentazione sarebbe ancora più
stupido che negli anni trenta, proprio perché le complementarietà tra
le produzioni locali e le produzioni all’estero si sono ancor più
aggravate.
Inoltre, questo vorrebbe dire non comprendere la natura della crisi
attuale. Come negli anni trenta (in contrasto con quella degli anni
ottanta), si tratta di una crisi di “sovra-accumulazione di profitti” e
di insufficienza della domanda popolare, ma geograficamente
polarizzata. I lavoratori supersfruttati sono in Cina e loro
consumatori in Europa o in America: il problema è di ottenere l’aumento
del potere d’acquisto dei lavoratori cinesi, ma non si può imporre un
“Wagner Act” o degli accordi di Matignon dal di fuori della Cina. La
crisi attuale è allo stesso tempo una crisi alimentare globale, e il
problema è la protezione delle agricolture nel Sud contro quelle del
Nord, non il contrario. Questa è infine una crisi climatica ed
energetica: nubi radioattive, il gas a effetto serra e il riscaldamento
globale si fanno beffe delle frontiere e delle tariffe doganali.
Dunque, quel che bisogna considerare è la progressiva eliminazione
delle cattive ragioni per frammentare la produzione. E queste ragioni
sono le differenze salariali, le differenze fiscali di regolamentazione
ambientale, e gli incentivi al trasporto, che rappresenta un’energia
artificialmente a buon mercato. Non si tratta più di proteggere i
mercati nazionali, ma dei compromessi ecologici e sociali avanzati, di
dimensioni globali, o almeno continentali.
Molti economisti liberali ritengono che, in effetti, il commercio
internazionale finirà spontaneamente per eliminare le differenziali
salariali. Già ora, la delocalizzazione in Cina non sarebbe più un
grande interesse, e quelli tra gli industriali che cercano bassi salari
si stanno rivolgendo a paesi ancora meno costosi, come il Vietnam.
Tuttavia, nessun argomento economico liberale tiene contro il “bisogno”,
per gli stati, di farsi concorrenza sull’abbassamento della fiscalità
sui profitti aziendali, e questo è uno dei motivi principali
dell’attuale crisi della finanza pubblica. Il ragionamento è lo stesso
per la legislazione ambientale.
Per quanto riguarda la perequazione dei salari che i liberali
promettono, essa è vera, ancora per lungo tempo rimarrà un pozzo senza
fondo: l’esercito industriale di riserva nell’Asia del Sud o in Africa,
per il momento almeno, inesauribile. Il liberalismo genera quindi
provvisoriamente una gara ai salari più bassi.
Siamo quindi ricondotti ad un problema non di protezionismo ma di
omogeneizzazione globale delle condizioni sociali, ambientali e fiscali.
A cosa bisogna aggiungere perché si tenga conto o meno, da parte di
ciascuna economia nazionale dei vincoli ambientali globali, quali la
lotta contro il cambiamento climatico. In tutti i casi, si tratta di
ottenere al livello mondiale una convergenza delle politiche fiscali,
sociali ed ecologiche.
Un protezionismo “universalista”
Naturalmente, per questa convergenza ci vorrà del tempo, lungo
traiettorie fortemente differenziate tra i diversi spazi socio-politici,
nazionali o continentali. In effetti, non tutti partono dallo stesso
livello di produttività del lavoro umano, non tutti storicamente hanno
contribuito allo stock di gas a effetto serra di origine antropica
attualmente nell’atmosfera, non tutti sono ugualmente esposti ai rischi
climatici. Tuttavia, possiamo misurare come questa strategia
“universalista” si oppone alla strategia “sovranista”, che ha lo scopo
di estendere gli stessi standard di progresso umano a tutto il mondo,
contro la logica del profitto opportunista.
Essa certamente richiederà misure di protezione per evitare che i
paesi impegnati in un processo di rapido miglioramento degli standard
sociali, fiscali e ecologici soffrano della concorrenza di paesi che non
vogliono fare nessuno sforzo in questa direzione. Tali misure
consisteranno nella creazione di una fiscalità ecologica che integri,
nel prezzo dei prodotti importati provenienti da aree con salari troppo
bassi, o irresponsabili nei confronti dei vincoli ambientali, il “costo
fantasma” che avrebbero dovuto pagare le imprese esportatrici, se
fossero state sottomesse alle stesse regole del paese d’importazione.
Tali misure protezionistiche si dovrebbero dissolvere man mano che
tutti i paesi adottassero le stesse regole sociali e ambientali: si
tratta di un protezionismo altruista che mira ad ottenere, per tutta
l’umanità, le misure politiche di miglioramento della qualità della vita
adottate nei paesi socialmente o ambientalmente avanzati. Il termine
“altruista”, ricordiamolo, non è puramente retorico: si tradurrà, come
ogni protezionismo, nell’aumento dei prezzi dei prodotti importati e
quindi di un calo (a breve termine) del potere di acquisto, e quindi sis
contreranno con la riluttanza “di sinistra” al protezionismo:
riluttanze che dovrenno essere vinte, tra le classi popolari, sono con
una politica di redistribuzione dei redditi interna alle società che
proteggono il loro progresso ecologico e sociale, imn maniera relativo
verso quelle che rifiuteranno questi progressi .
La radice del problema, nell’attuale aggrovigliamento mondializzato
dei processi di produzione, e di fronte alla natura globale dei vincoli
ambientali, è che non disponiamo di istanze politiche sovranazionali
che permettano l’adizione simultanea di questi standard sociali,
fiscali e ambientali. L’Unione europea rappresenta il punto più
avanzato (anche se troppo poco avanzato!), a livello globale, di un
processo di convergenza delle norme, sotto l’egida di un dispositivo
politico a vocazione federale. È per questo che gli ambientalisti
sostentono la federalizzazione e la democratizzazione più veloce
possibile della Ue, così come sostengono il carattere vincolante degli
accordi internazionali in materia di ambiente.
Convinzione e sanzioni
Che dice “legge comune e carattere vincolante” solleva due problemi:
l’adesione e la sanzione. La sanzione consiste appunto nelle misure di
protezione. Il tal paese non vuole fare nulla nella lotta contro
l’effetto serra? I paesi che vogliono andare avanti nella tutela si
proteggeranno non comprando le sue merci, o addebidandoli un sovracosto
fantasma corrispondente alle misure che non ha voluto adottare. Ma qui
ritorniamo alle nostre considerazioni introduttive: queste sanzioni …
aumentano il prezzo delle merci importate, anche per i lavoratori a
basso reddito dei paesi “virtuosi”. Ogni protezionismo urterà con questo
problema, così come solleverà le proteste indignate delle
multinazionali e delle élites dei paesi esportatori che si curano poco
delle condizioni sociali e ambientali imposte al proprio popolo.
Per questo il protezionismo a vocazioen universalista
altermondialista presuppone un processo intenso di dibattito, di
spiegazione e la conversione ai valori sociali ed ecologici che pretende
di difendere. Non ci sarà sostegno popolare a misure protezionistiche
nei paesi protetti, né accettazione da parte dei lavoratori dei paesi
esportatori di norme sociali in nome delle quali certi paesi si
oppongono ai loro prodotti, se non ci sarà uno sviluppo potente e
transnazionale ai valori della giustizia sociale e ambientale. E’ quiche
l’educazione popolare e e le iniziative della società giocano un ruolo
cruciale.
Così, le esperienze del commercio equo, grazie alle quali consumatori
occidentali sono disposti a pagare qualche centesimo in più il
pacchetto di caffè, se si garantisce loro che gli agricoltori che lo
hanno prodotto sono stati correttamente pagati, possono sembrare
marginali agli occhi degli economisti. Ma in realtà si tratta di una
avanguardia nella battaglia ideologica perché tutto il commercio
mondiale divenga equo: e ciò richiederà accordi internazionali
vincolanti.
Oggi, partecipare al commercio equo, è un modo di votare con i propri
borsellini per la supremazia delle norme dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (Oil) e degli accordi internazionali in
materia di ambiente, a fronte delle regole di libero scambio
dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Questo primato,
naturalmente, va da sé quando si tratta di misure fitosanitarie dettate
dalle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms): tutti riconoscono che
un paese ha il diritto di proteggere la propria salute da rischi che
vengono dalle importazioni. Il passo successivo è far sì che accada la
stessa cosa per i rischi sociali e ambientali. E questa è una battaglia
da combattere in tutti i paesi, anche negli strati popolari che
rinunceranno difficilmente (nel Nord) alle importazioni a basso costo, e
sono pronti (nel Sud) a sacrificare tutto per ottenere un posto di
lavoro .
***
Mentre ero presidente della delegazione del Parlamento europeo presso
la Comunità Andina delle Nazioni, ho incontrato a Guayaquil (Ecuador) i
sindacalisti dei raccoglitori di banane. Che, le lacrime agli occhi,
ci raccontavano come i bambini erano pagati per raccogliere grappoli di
banane ancora purulente di insetticidi cancerogeni. Quando ho chiesto
loro: “Volete che proponga all’Unione europea di vietare le
importazioni di banane ecuadoriane, finché queste pratiche non saranno
scomparse?”, sono rimasti perplessi … Di fronte alla stessa domanda, il
presidente della Centyrale autentica dei lavoratori del Messico aveva
risposto seccamente: “Non ha alcun senso lottare per il miglioramento
dei diritti sociali in Messico, se le aziende che non li rispettano non
vengono sanzionate”.
Il protezionismo universalista richiederà molto coraggio e molta
saggezza, qui e là. E’ il coraggio che è mancato ai sindacalisti
dell’Ottocento per far vietare il lavoro minorile, anche di fronte
all’opposizione da parte dei loroo colleghi, che “aavevano bisogno” del
salario dei loro figli.

Nessun commento:
Posta un commento