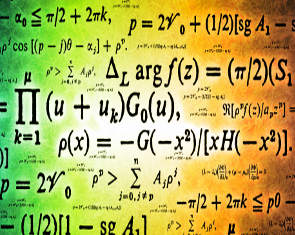 Quest’enunciato
non è di per sé evidente. Che la matematica sia un pensiero, è stato
più volte sostenuto, innanzitutto da Platone, che però avanza in
proposito numerose riserve, e più volte negato, in particolare da
Wittgenstein. Si tratta di un enunciato indubbiamente sottratto alla
dimostrazione. Forse è il punto di impasse della stessa
matematizzazione, e dunque il reale della matematica. Ma il reale, più
che essere conosciuto, viene dichiarato. L’oscurità di quest’enunciato
risulta da quanto sembra imporsi come una concezione intenzionale del
pensiero: in questa concezione, ogni pensiero è pensiero d’un oggetto,
che ne determina l’essenza e lo stile. La matematica può allora essere
considerata un pensiero proprio nella misura in cui esistono degli
oggetti matematici, e l’indagine filosofica concerne la natura e
l’origine di questi oggetti. Ora, è chiaro che una tale supposizione è
problematica: in quale senso le idealità matematiche possono essere
dichiarate esistenti? Ed esistenti nella forma generica dell’oggetto?
Tale difficoltà è presa in esame nel libro M della Metafisica di
Aristotele, a proposito di ciò che egli chiama le matematikà,
le cose matematiche, o correlati supposti della scienza matematica. Se
si abborda la questione della matematica come pensiero che concerne
l’oggetto o l’oggettività, la soluzione di Aristotele è mio avviso
definitiva.
Quest’enunciato
non è di per sé evidente. Che la matematica sia un pensiero, è stato
più volte sostenuto, innanzitutto da Platone, che però avanza in
proposito numerose riserve, e più volte negato, in particolare da
Wittgenstein. Si tratta di un enunciato indubbiamente sottratto alla
dimostrazione. Forse è il punto di impasse della stessa
matematizzazione, e dunque il reale della matematica. Ma il reale, più
che essere conosciuto, viene dichiarato. L’oscurità di quest’enunciato
risulta da quanto sembra imporsi come una concezione intenzionale del
pensiero: in questa concezione, ogni pensiero è pensiero d’un oggetto,
che ne determina l’essenza e lo stile. La matematica può allora essere
considerata un pensiero proprio nella misura in cui esistono degli
oggetti matematici, e l’indagine filosofica concerne la natura e
l’origine di questi oggetti. Ora, è chiaro che una tale supposizione è
problematica: in quale senso le idealità matematiche possono essere
dichiarate esistenti? Ed esistenti nella forma generica dell’oggetto?
Tale difficoltà è presa in esame nel libro M della Metafisica di
Aristotele, a proposito di ciò che egli chiama le matematikà,
le cose matematiche, o correlati supposti della scienza matematica. Se
si abborda la questione della matematica come pensiero che concerne
l’oggetto o l’oggettività, la soluzione di Aristotele è mio avviso
definitiva.
Tale soluzione si inscrive tra due limiti.
1. Da
una parte si deve escludere di poter accordare l’essere o l’esistenza
agli oggetti matematici, intendendolo come un essere separato, che
costituirebbe un campo preesistente ed autonomo della donazione
oggettiva. La tesi qui criticata è attribuita a Platone; e di fatto, i
reali discendenti di Aristotele, ovvero i moderni empiristi
anglo-sassoni, chiamano «platonismo» la supposizione di un’esistenza
soprasensibile e separata delle idealità matematiche, e fanno valere,
contro una tale supposizione, che gli oggetti matematici sono costruiti.
Aristotele dirà allora: le matematikà non sono affatto degli
esseri separati. Se così fosse, dovremmo averne un’intuizione
intelligibile originaria, ma nulla può attestarla. Non possono dunque
servire ad identificare la matematica come pensiero singolare. Diciamo
che, per Aristotele, nessuna separazione ontologica può garantire la
separazione epistemologica; e questo in particolare se si tratta dello
scarto tra la fisica, che si interessa al sensibile, e la matematica,
poiché: «è evidente che anche gli enti matematici non potranno esistere
separati dai sensibili» (M, 2, 10).
2. Simmetricamente, è
altrettanto impossibile che gli oggetti matematici siano immanenti al
sensibile. Questo punto Aristotele lo tratta nel libro B. L’argomento
principale è che l’immanenza di idealità indivisibili dai corpi
sensibili porterebbe con sé l’indivisibilità di questi corpi; o che
l’immanenza delle idealità immobili porterebbe con sé l’immobilità dei
corpi sensibili. Cosa che ripugna all’esperienza. Il fondo
incontestabile di questa tesi è che ogni matematicità immanente o
infetta l’oggetto matematico di predicati sensibili che gli sono
manifestamente estranei, come la temporalità e la corruttibilità, o
infetta i corpi sensibili con predicati intelligibili, che sono a loro
volta estranei a questi, come l’eternità e la trasparenza concettuale.
Se lo si mette in relazione con il campo dell’esperienza, l’oggetto
matematico non è né separabile né inseparabile. Non è né trascendente né
immanente. La verità è che, per essere precisi, non ha essere. O, più
precisamente: in nessun luogo l’oggetto matematico esiste in atto. Come dirà Aristotele, o le matematikà
non esistono affatto, oppure in ogni caso non esistono in maniera
assoluta. Diciamo che l’oggettività matematica è uno pseudo-essere,
sospeso tra l’atto puro separato, il cui nome supremo è Dio, e le
sostanze sensibili, o cose realmente esistenti. La matematica non è né
fisica né metafisica. Ma allora, che cos’è? In realtà è un’attivazione
finzionale, compiuta là dove l’esistenza in atto viene a mancare.
L’oggettività matematica esiste in potenza nel sensibile, e vi risiede
nella forma di una latenza definitiva del suo atto.
Così, è vero
che un uomo detiene in potenza l’uno aritmetico, o che un corpo detiene
in potenza tale o tal’altra forma pura. L’uno aritmetico o la sfera
geometrica non esistono a parte, né esistono come tali in un uomo o in
un pianeta. Il pensiero può però attivare l’uno o la sfera a partire
dall’esperienza di un organismo o di un oggetto. Cosa vuol dire
attivare? Vuol dire esattamente: trattare come esistente in atto ciò che
non esiste che in potenza. Trattare come essere uno pseudo-essere.
Trattare come separato ciò non lo è. Questa è la definizione di
Aristotele: coloro che conoscono e praticano l’aritmetica e la geometria
giungono, a suo avviso, a risultati eccellenti «ponendo come separato
ciò che non lo è». La conseguenza di tale finzione è che la norma delle
matematiche non può essere il vero, poiché il vero non si lascia
approssimare da una finzione. La norma delle matematiche è il bello.
Poiché il matematico con le sue finzioni separa innanzitutto relazioni
d’ordine, simmetrie, entità concettuali semplici e trasparenti. Ora,
osserva Aristotele, «le forme più alte del bello sono l’ordine, la
simmetria, il definito». Ne risulta che «il bello è l’oggetto principale
delle dimostrazioni matematiche». Si può allora modernizzare la
conclusione definitiva di Aristotele. Per far questo, basta domandarsi:
cos’è che ha potenza di attivare «l’essere in potenza», o: cos’è che ha
potere di separare ciò che non è separato? È evidente che per noi
moderni si tratta del linguaggio. Come osserva Mallarmé in una famosa
citazione, se dico «un fiore» lo separo da ogni bouquet. Se dico «sia
una sfera», la separo da ogni oggetto sferico. Su questo punto, matema e
poema sono indiscernibili.
Si può allora ricapitolare la dottrina
1. La matematica è il quasi-pensiero di uno pseudo-essere. 2. Questo
pseudo-essere è distribuito in quasi-oggetti (per esempio i numeri e le
figure, ma anche le strutture algebriche, topologiche, etc.). 3. Questi
quasi-oggetti non sono dotati di alcuna specie di esistenza in atto, non
essendo né trascendenti né immanenti al sensibile. 4. Sono in effetti
delle creazioni linguistiche estratte mediante l’uso di finzioni dagli
strati latenti, o inattivabili, o non separabili, degli oggetti reali.
5. La norma che regge la finzione separatrice è la bellezza trasparente
delle relazioni semplici che essa costruisce. 6. La matematica è dunque
alla fin fine un’estetica rigorosa. Essa non ci dice niente
sull’essere-reale, ma a partire da esso produce la finzione di una
consistenza intelligibile la cui regola è esplicita. E infine: 7.
Considerata come pensiero, la matematica non è pensiero del proprio
pensiero. Infatti, installata nella sua stessa finzione, non può che
credervi. Si tratta di un punto su cui Lacan insisteva giustamente: il
matematico è innanzitutto colui che crede in modo irremovibile alle
matematiche. La filosofia spontanea del matematico è il platonismo,
poiché essendo il suo atto quello di separare ciò che non è separato,
egli ottiene per mezzo di questa attivazione finzionale lo spettacolo
ideale del suo risultato. Per lui tutto accade come se gli oggetti
matematici esistessero in atto. Più profondamente: il pensiero
matematico, come ogni finzione, è un atto. Non può essere altro, dato
che non vi è nulla da contemplare. Come dice Aristotele in una formula
piuttosto concisa, nel caso delle matematiche, e noesis energheià l’intelletto è atto.
Nelle
matematiche, l’atto che manca agli oggetti ritorna dalla parte del
soggetto. Preso com’è nell’atto di attivazione finzionale che
costituisce il proprio pensiero, il matematico ne misconosce la
struttura. Questa è anche la ragione per la quale la dimensione estetica
è occultata da una pretesa cognitiva. Il bello è la vera causa
dell’attività matematica, ma nel discorso matematico tale causa è una
causa assente. Non è reperibile se non attraverso i suoi effetti: «Se le
scienze matematiche non nominano il bello ciò non significa che esse
non se ne occupino, poiché esse ne mostrano gli effetti e i rapporti». È
il filosofo che deve dare un nome alla causa reale dell’atto
matematico, e dunque pensare il pensiero matematico secondo ciò a cui
esso è veramente destinato. Questa concezione è a mio avviso ancor oggi
dominante e si manifesta in quattro sintomi principali: a) La critica di
ciò che è supposto esistere in ciò che il termine «platonismo» indica è
pressappoco consensuale in tutte le concezioni contemporanee della
matematica. Analogamente in esse si possono trovare le ragioni per le
quali i matematici sono dei platonici spontanei, o «ingenui». b) Il
carattere costruito e linguistico delle entità o strutture matematiche è
quasi universalmente ammesso. c) Anche se l’estetica non è sempre
convocata in quanto tale, molti dei temi oggi consueti sono ad essa
omogenei. Ad esempio, l’eliminazione della categoria di verità; la
tendenza al relativismo (vi sarebbero più matematiche differenti, ed in
definitiva sarebbe questione di gusto); ed infine l’approccio logico
delle architetture matematiche, che le tratta come grandi forme il cui
protocollo di costruzione sarebbe decisionale, ed il cui referente, o
essere proprio, ovvero la determinazione attraverso il pensiero di ciò
che è pensato, rimane non assegnabile. Il che è conforme
all’orientamento di Aristotele, il quale riconosce espressamente alle
matematiche una superiorità formale, ciò che egli chiama un’anteriorità
logica, ma questo per meglio negar loro l’anteriorità sostanziale, o
ontologica. Poiché, dice Aristotele: «l’anteriorità sostanziale è la
divisione degli esseri che, separati, prendono il sopravvento grazie
alla facoltà dell’esistenza separata». La separazione puramente fittizia
dell’oggetto matematico è dunque, in dignità ontologica, inferiore alla
separazione reale delle cose. Inversamente, la trasparenza logica delle
matematiche è esteticamente superiore alla sostanzialità separata delle
cose. Ciò che è integralmente riprodotto oggi nella distinzione
canonica, essa stessa intra-linguistica, tra scienze formali e scienze
empiriche. d) L’incontestabile supremazia odierna della visione
costruttivista, o intuizionista, sulla visione formalista e unificata
del fondamento, così come sull’evidenza della logica classica.
L’estetica del grande edificio iniziato da Bourbaki era un’estetica
globale che si potrebbe chiamare arborescente. Sul solido tronco della
logica e di una teoria omogenea degli insiemi, nascevano i rami
simmetrici dell’algebra e della topologia, che si re-incrociavano più in
alto all’altezza delle strutture concrete più «fini», e componevano la
disposizione ramificata del fogliame. Oggi si parte piuttosto da
concrezioni già di per sé complesse, e si tratta di piegarle e
dispiegarle secondo la loro singolarità, o di trovare il principio della
loro decostruzione-ricostruzione, senza preoccuparsi di un piano
d’insieme o di un fondamento deciso. L’assiomatica è lasciata cadere a
favore di un’apprensione mobile delle complessità e delle correlazioni
sorprendenti. Il rizoma di Deleuze prende il posto dell’albero di
Cartesio. L’eterogeneo dà da pensare più che l’omogeneo. Una logica
intuizionista o modale è più appropriata a quest’orientamento
descrittivo che non la rigidezza della logica classica, in cui vale il
principio del terzo escluso. La questione è dunque: considerando la
matematica come pensiero, siamo votati ad una versione linguistica
dell’aristotelismo? Non ne sono affatto convinto. L’ingiunzione della
matematica contemporanea mi sembra piuttosto essere quella di riprendere
il platonismo, ed innanzitutto rendere noto quale fosse il suo intento
reale, intento interamente occultato dall’esegesi di Aristotele.
Nondimeno, al punto in cui ci troviamo non prenderò direttamente la
strada che potremo chiamare la rettificazione platonica. La questione
che vorrei cominciare a prendere in esame è limitata. Poiché in
definitiva, se si sostiene che la matematica è pensiero, si tratta di
iniziare ad esaminare il pensiero di questo pensiero, ed è pertinente
occuparsi dei momenti in cui la matematica sembra convocata a pensarsi
da sé, a dire ciò che essa è. Questi momenti, si sa, ricevono il nome
convenzionale di «crisi», o «crisi dei fondamenti». È il caso della
crisi degli irrazionali nella matematica detta pitagorica, o della crisi
legata ai paradossi della teoria degli insiemi alla fine del secolo
scorso, poi dei diversi teoremi di limitazione dei formalismi scoperti
negli anni trenta. C’è stata anche una crisi a proposito dell’utilizzo
anarchico dell’infinitamente piccolo agli inizi XVIII° secolo, e
un’altra relativa alla geometria, con la scoperta del carattere
indecidibile del postulato di Euclide sulle parallele. Ci si è
interrogati sul carattere di queste crisi, se fossero crisi interne alla
matematica, o invece si trattasse di crisi strettamente filosofiche,
che importavano nel dibattito tra matematici opzioni di pensiero legate
all’esistenza di ciò che Louis Althusser chiamava la «filosofia
spontanea degli scienziati». Althusser sosteneva che nelle scienze non
c’era nessun tipo di crisi. C’erano certo delle discontinuità, dei
bruschi rimaneggiamenti qualitativi. Questi momenti testimoniavano
progresso e creazione, e non vicoli ciechi o crisi. Ma proprio in
occasione di queste rotture avevano ineluttabilmente luogo delle lotte
tra tendenze filosofiche, e questo anche negli ambiti scientifici in
questione, lotte il cui obiettivo era in realtà risistemare il modo
secondo cui le correnti filosofiche si servono delle scienze per i loro
fini, che in ultima istanza sono fini politici. Partiremo qui dalla
constatazione seguente: ci sono dei momenti singolari in cui la
matematica sembra dover pensare il proprio pensiero, e questo a partire
da finalità interamente matematiche. In cosa consiste questa operazione?
Tutto si gioca in effetti in alcuni enunciati con cui il pensiero
matematico si scontra, come se essi fossero, nel campo matematico, il
segno dell’impossibile. Questi enunciati sono chiaramente di tre tipi: –
O si tratta di una contraddizione formale, dedotta da un insieme di
presupposti la cui evidenza e coesione sembravano nondimeno indubbie. Ci
si scontra qui con il paradosso. È il caso della teoria formale delle
classi, nello stile di Frege, teoria che inciampa sul paradosso di
Russell. In questo caso l’evidenza qui obbligata ad incontrare il
proprio impossibile è quella che assegna a una proprietà qualunque
l’insieme dei termini che possiedono questa proprietà. Nulla di più
chiaro di tale teoria dell’estensione di un concetto; e nondimeno, come
una prova reale, giunge il caso che fa affiorare in quest’evidenza
un’inconsistenza intrinseca. – Il secondo caso è quello in cui una
teoria condivisa è diagonalizzata in un punto da un’eccezione, o da un
eccesso, che obbliga a considerare questa teoria, prima creduta
assolutamente generale, una teoria regionale, o decisamente particolare,
o ristretta. Questo accade nella dimostrazione dell’incommensurabilità
della diagonale del quadrato, se si intende per misura un numero
irrazionale. Per i pitagorici la reciprocità dell’essere e del numero
era assicurata da un’evidenza, l’assegnazione di una coppia di numeri
interi ad ogni rapporto. Ma quest’evidenza è rovinata dimostrativamente
da un rapporto geometrico in eccesso su ogni coppia di numeri interi che
si pretendeva assegnargli come misura. Bisogna dunque ripensare il
pensiero in cui si dispiegava la numericità essenziale dell’essere, e
dunque ripensare il pensiero matematico in quanto tale. – Infine, il
terzo caso è quello in cui un enunciato di cui non ci si è accorti è
isolato come condizione di risultati tenuti per certi, mentre, preso di
per sé, tale enunciato sembra non sembra poter essere supportato dalle
norme condivise riguardanti il pensiero matematico. È il caso
dell’assioma di scelta. I grandi analisti francesi della fine del secolo
scorso ne facevano implicitamente uso nelle loro dimostrazioni; ma
l’esplicitazione formale di questo assioma parve loro eccedere
assolutamente ciò che essi potevano accettare in quanto manipolazione
dell’infinito; e soprattutto, vi scorsero una trasgressione illegittima
della visione costruttivista che essi si facevano del pensiero
matematico. L’assioma di scelta consiste infatti nell’ammettere un
insieme infinito assolutamente indeterminato, la cui esistenza è
affermata, sebbene esso sia linguisticamente indefinibile e,
proceduralmente, non sia possibile costruirlo. Si può dunque sostenere
che il pensiero matematico si riporta a sé a partire dalla forzatura di
una ostacolo reale, o a partire dall’insorgenza necessaria, nel proprio
campo, di un punto d’impossibile. Questo ostacolo è dell’ordine del
paradosso, che conduce all’inconsistenza; della diagonale, che conduce
all’eccesso; o dell’individuazione di un enunciato latente, che conduce
all’indefinito e al non costruibile. Qual è allora la natura di questa
torsione su di sé della matematica, se la si considera a partire da ciò
che il suo ostacolo interno comanda? Ciò che affiora alla superficie
concerne ciò che, dell’ordine del pensiero matematico, riguarda l’atto, o
la decisione; e nello stesso movimento, è necessario prendere
posizione, poiché si è, se così posso dire, di fronte all’atto, sulla
norma della decisione che esso compie. Ora, ad ogni modo, in questa
decisione obbligatoria, è l’essere che è in questione; o il modo secondo
il quale la matematica assume per suo conto l’enunciato di Parmenide:
«lo stesso è allo stesso tempo pensare e essere». Riprendiamo i nostri
esempi. Per i Greci, a partire dall’ingiunzione rappresentata
dall’incommensurabile reale, il pensiero è costretto ad optare per un
altro nodo tra essere e numero, tra geometrico ed aritmetico, decisione
il cui nome proprio è Eudosso. Dinanzi al paradosso di Russell, è
necessario ridurre i poteri della lingua sulla determinazione del
molteplice, decisione il cui nome proprio è Zermelo. E quanto
all’assioma di scelta, ciò a cui esso chiama il pensiero è una decisione
radicale sull’infinito attuale indeterminato, decisione che del resto
divide da allora i matematici. In ogni caso, si tratta di decidere in
quale senso, e a partire dalla disposizione immanente di quali limiti,
il pensiero matematico è coestensivo all’essere che ne sostiene la
consistenza.
Diremo dunque che nel momento in cui la matematica si
imbatte nel paradosso e nell’inconsistenza, nella diagonale e
nell’eccesso, o ancora in una condizione indefinita, essa giunge a
pensare ciò che nel suo pensiero è dell’ordine di una decisione
ontologica. Si tratta esattamente di un atto che vincola durevolmente il
reale dell’essere le cui connessioni e configurazioni essa si farà
carico di determinare. Ma, confrontata così alla propria dimensione
decisionale, la matematica non può che essere in preda alla questione
della propria norma, ed in particolare: della norma delle asserzioni di
esistenza che il pensiero è in grado di sostenere. Bisogna far venire
all’esistenza dei numeri il cui principio non è più la composizione di
unità? Bisogna ammettere che esistano insiemi infiniti attuali non
numerabili? A quali condizioni si può garantire che un concetto ben
formato ammette un’estensione identificabile? Come si legano
l’asserzione di esistenza e il protocollo di costruzione? Si può
ammettere che esista una configurazione intelligibile di cui sia
impossibile esibire un solo caso? Tali questioni verranno decise secondo
una norma immanente che non costituisce il pensiero, ma l’orienta.
Chiameremo orientamento nel pensiero ciò che in questo pensiero regola
le asserzioni di esistenza. Ovvero ciò che autorizza formalmente
l’inscrizione di un quantificatore esistenziale all’inizio di una
formula che fissa delle proprietà che si suppongono date in una regione
d’essere. O ciò che, ontologicamente, fissa l’universo della
presentazione pura del pensabile. Un orientamento nel pensiero si
estende non solo alle asserzioni fondatrici, o agli assiomi, ma anche ai
protocolli dimostrativi, dato che il loro obiettivo è esistenziale. Per
esempio, si ammetterà che si possa affermare l’esistenza solo di ciò
per cui l’ipotesi di un’inesistenza porta ad un’impasse logica? Il
ragionamento per l’assurdo funziona in questo modo. Ammetterlo oppure no
riguarda, esemplarmente, l’orientamento del pensiero, classico se lo si
ammette, intuizionista se non lo si ammette. La decisione concerne
allora la via di accesso, che il pensiero determina in sé, a ciò che
esso stesso dichiara esistere. Il cammino verso l’esistenza orienta il
procedere discorsivo. A mio avviso è erroneo dire che due orientamenti
prescrivono due matematiche diverse, ovvero due pensieri diversi. Gli
orientamenti si affrontano all’interno di un pensiero unico. Nessun
matematico classico ha mai messo in dubbio la matematicità riconoscibile
della matematica intuizionista. In ogni caso, si tratta dell’identità
necessaria tra pensiero e essere. Ma l’esistenza, che è
contemporaneamente ciò che il pensiero dichiara e ciò di cui l’essere
garantisce la consistenza, è considerata secondo orientamenti diversi.
Si può infatti chiamare esistenza ciò per cui decisione ed incontro,
atto e scoperta sono indiscernibili. Gli orientamenti nel pensiero
concernono proprio le condizioni di questa indiscernibilità. Si dirà
dunque che vi sono dei momenti in cui la matematica, frangendosi su di
un enunciato che attesta in un punto la venuta di un impossibile, volge
lo sguardo alle decisioni che l’orientano. Essa coglie allora il proprio
pensiero, non più a partire dalla propria unità dimostrativa, ma
secondo la diversità immanente degli orientamenti nel pensiero. La
matematica pensa la propria unità come interiormente esposta alla
molteplicità degli orientamenti nel pensiero. Una «crisi» della
matematica è un momento in cui essa è costretta a pensare il proprio
pensiero come molteplicità immanente della propria unità. È in questo
punto, credo, e solo in questo punto, che la matematica, ovvero
l’ontologia, funziona come condizione della filosofia. Diciamo questo:
la matematica si rapporta al proprio pensiero secondo il proprio
orientamento. È la filosofia che ha il compito di continuare questo
gesto attraverso una teoria generale degli orientamenti nel pensiero.
Che ogni pensiero possa pensare la propria unità solo come esposizione
alla molteplicità che l’orienta, è ciò di cui la matematica non può
rendere conto, ma è anche ciò che essa manifesta esemplarmente. Il
rapporto completo del pensiero matematico con il proprio pensiero,
suppone che la filosofia, sotto condizione della matematica, tratti la
questione: che cos’è un orientamento nel pensiero? E ancor più: che cosa
fa sì che l’identità dell’essere e del pensiero si effettui secondo una
molteplicità immanente di orientamenti? Perché bisogna sempre decidere
ciò che esiste? Poiché la questione è che l’esistenza non è affatto la
donazione primigenia. L’esistenza è precisamente l’essere stesso, in
quanto il pensiero lo decide. E questa decisione orienta essenzialmente
il pensiero. Bisognerebbe dunque disporre di una teoria degli
orientamenti nel pensiero, come territorio reale di ciò che il pensiero
della matematica, in quanto pensiero, può attivare. In L’Essere e
l’Evento ho proposto un trattamento sommario di questo punto, e non
posso ritornare qui sul basamento tecnico che lo sorregge. Vi si possono
rintracciare tre orientamenti maggiori, identificabili simultaneamente
nei momenti di crisi della matematica, e nei rimaneggiamenti concettuali
della filosofia. Questi orientamenti sono l’orientamento
costruttivista, l’orientamento trascendente e l’orientamento generico.
Il primo norma l’esistenza attraverso delle costruzioni esplicite e
subordina in definitiva il giudizio di esistenza a dei protocolli
linguistici finiti e controllabili. Diciamo che ogni esistenza si
sostiene su di un algoritmo, che permette effettivamente di esporre un
caso di ciò la cui esistenza è in questione. Il secondo, il
trascendente, norma l’esistenza attraverso l’ammissione di ciò che si
può chiamare una sovra-esistenza, o un punto di arresto gerarchico che
dispone, al di qua di sé stesso, l’universo di tutto ciò che esiste.
Diciamo che questa volta l’intera esistenza si inscrive in una totalità
che gli assegna un posto. Il terzo pone che l’esistenza non ha altra
norma se non la consistenza discorsiva. Esso privilegia le zone
indefinite, i molteplici sottratti a ogni collezione predicativa, i
punti di eccesso e le donazioni sottrattive. Diciamo che ogni esistenza è
presa in un’erranza che si situa diagonalmente rispetto ai montaggi che
sono supposti sorprenderla. È abbastanza chiaro che questi tre
orientamenti sono, metaforicamente, di natura politica. Sostenere che
l’esistenza deve mostrarsi secondo un algoritmo costruttivo, o che essa è
predisposta in un Tutto, o che essa è una singolarità diagonale,
orienta il pensiero secondo un’accezione di ciò che è ogni volta
particolare, «ciò che è» essendo qui pensato a partire dalla decisione
di esistenza. O ciò che è, è ciò di cui c’è un caso, o ciò che è è un
posto in un Tutto; o ciò che è, è ciò che si sottrae a ciò che è. Si
potrebbe dire: politica delle particolarità empiriche, politica della
totalità trascendente, politica delle singolarità sottratte. Diciamo,
per essere brevi: le democrazie parlamentari, Stalin, e, senza dubbio,
ciò che si dichiara un po’ oscuramente oggi, una politica generica, una
politica dell’esistenza come sottrazione allo Stato, o di ciò che esiste
solamente in quanto non è calcolabile. È magnifico che questi tre
orientamenti siano matematicamente leggibili, e questo anche nella sola
teoria degli insiemi. La dottrina degli insiemi costruibili di Gödel
fornisce una solida base per il primo, la teoria dei grandi cardinali
per il secondo, la teoria degli insiemi generici per il terzo. Ma ben
altri esempi più recenti ci mostrerebbero come ogni progresso matematico
finisce per esporre, nell’unicità contingente del suo movimento, i tre
orientamenti. Ogni movimento reale è immediatamente la presentazione,
nel punto d’essere che convoca il pensiero, dei tre orientamenti. Ogni
movimento reale confronta la triplicità formale delle decisioni di
esistenza. Terremo presente a questo punto, che è di grande aiuto in
tutte le situazioni concrete: nessuna seria querelle tra dispositivi di
pensiero oppone tra loro interpretazioni di un’esistenza riconosciuta da
tutti. È invece vero il contrario: è sull’esistenza stessa che
l’accordo non si raggiunge, poiché è l’esistenza ciò che viene deciso.
Ogni pensiero è polemica. Ma non si tratta affatto di un conflitto tra
interpretazioni. Si tratta di un conflitto di giudizi di esistenza. Ecco
perché nessun vero conflitto di pensiero ammette una soluzione; il
consenso è il nemico del pensiero, perché pretende che si condivida
l’esistenza. Ma l’esistenza è giustamente, al cuore del pensiero, ciò
che non può essere condiviso. La matematica possiede questa virtù: non
presentare alcuna interpretazione. Il reale non vi si mostra nella forma
di interpretazioni disparate. Vi si dimostra come sprovvisto di senso.
La conseguenza è che quando la matematica si volge al proprio pensiero,
essa mette a nudo i conflitti di esistenza, e ci fa pensare che ogni
coglimento dell’essere suppone, rispetto all’esistenza, una decisione
che, senza garanzia né arbitraggio possibile, orienta decisivamente il
pensiero. L’elogio delle «matematiche severe» da parte di Lautréamont è
ben calibrato. Non sono tanto il formalismo, o il concatenamento
dimostrativo, ad essere severi, ma la manifestazione di una massima di
pensiero che si potrebbe formulare così: è quando decidi ciò che esiste
che leghi il tuo pensiero all’essere. Ma allora ti trovi preso,
inconsapevolmente, nell’imperativo di un orientamento.

Nessun commento:
Posta un commento