«Era una situazione talmente esplosiva che per far saltare tutto sarebbe
bastato gettare in sala anche un fiammifero spento», commenta un
vecchio parlamentare del Pci nella piazza Capranica trasformata in una
bolgia. Sono le undici e mezzo di sera, l’assemblea del Pd si è conclusa
da poco, fuori ci sono manifestini strappati, telecamere abbandonate,
un megafono, dirigenti in fuga.
Sarebbe bastato un fiammifero spento, già, ma la candidatura di
Franco Marini formalmente proposto da Pier Luigi Bersani ma in realtà
scelto dal Cavaliere-Caimano-Giaguaro ha l’effetto di un detonatore,
scatena una guerra termonucleare nel cuore del Pd, una riunione
pazzesca, una notte mai vista, neppure nella storia tormentata delle
elezioni presidenziali della Prima Repubblica. All’epoca, nella Dc, si
usavano con millimetrica precisione i pugnali e i veleni, tutti
ossequiavano il candidato ufficiale e poi lo impallinavano il giorno
dopo con il voto segreto. Ieri notte no, alla vigilia della votazione
più importante il Pd si spacca in mille pezzi davanti a tutti. E ci sono
nuovi protagonisti, imprevisti. Fanfani non sarebbe mai finito in
liveblogging, nessuno ha mai ispezionato la carriera di Forlani su
wikipedia, meno che mai gli aspiranti franchi tiratori avrebbero
rivelato le loro intenzioni su facebook. E mai il capo della cordata
ribelle sarebbe andato in tv a sparare sul quartier generale come fa
Matteo Renzi mentre il povero Bersani prova a domare la platea
infuriata.
Ci vorrebbe un politico ruvido e carismatico, un sindacalista rotto a
ogni furbizia, ci vorrebbe un Franco Marini per placare l’ira dei
parlamentari Pd e portare l’assemblea a una conclusione positiva. Una
volta, era una sera di nove anni fa, durante a cena con Arturo Parisi e
Rosy Bindi dopo un incontro a Sinalunga, Marini raccontò di quella volta
che da segretario della Cisl lo chiamarono in piena notte perché i suoi
delegati non volevano firmare il contratto della funzione pubblica. Si
alzò, si vestì, andò davanti al ministero, convocò i suoi. «Non volete
firmare? Benissimo!». E si mise a strappare il contratto, pagina per
pagina. Finché furono proprio i contrari a bloccarlo: «Basta! Firmiamo».
Ma Marini, qui dentro, non c’è. Non è stato eletto senatore alle
elezioni di febbraio. I candidati, i cavalli di razza, i Prodi e gli
Amato, i D’Alema e i Veltroni, i saggi come Castagnetti, tutti quelli
che saprebbero guidare gli umori del gruppo sono fuori di qui, paradossi
della rottamazione. E il segretario Bersani, nel momento della verità,
si affloscia, si immalinconisce, quando propone Marini la sua voce è
così flebile che lo sentono e applaudono (per cortesia) solo nelle prime
file. Dietro ululati, proteste. E standing ovation per chi va al
microfono a dichiarare il dissenso. Come Walter Tocci, sostenitore di
Rodotà e di Prodi, che fa l’elogio del franco tiratore: viene giù il
teatro.
Contro Marini parlano i renziani e la sinistra del partito, Pippo
Civati lucido e efficacissimo e Matteo Orfini che chiede di ripensarci
prima dello schianto, lo yin e lo yang, i deputati di prima nomina,
giovani turchi o meno sono i più inferociti, «noi non lo votiamo». E non
è un problema di persona, benché il caratteraccio di Franco non aiuti:
in molti lo conoscono solo perché nelle assemblee e nelle direzioni del
partito interviene per rimbrottare ogni istanza di rinnovamento, come
fece sei mesi fa quando si schierò contro le primarie: «Sono una
cazzata, spaccheranno il partito», addentò la pipa. Aveva torto, ma
almeno Marini è un combattente a viso aperto. Mentre il gruppo dirigente
del Pd è uno stato maggiore che si è fatto imporre il candidato dal
nemico Berlusconi e non sa neppure spiegare perché. Perché è stata
cambiata la linea di due mesi, che cercava un rapporto con il Movimento 5
Stelle per un governo «del cambiamento» e chiudeva ogni strada al
rapporto con il Cavaliere.
Invece, ieri sera bastava girare l’angolo per incontrare uno dei
vincitori della serata: Silvio Berlusconi. All’assemblea del Pdl, durata
pochi minuti, tutt’altro clima. La Santanché in bicicletta. Formigoni
rivestito con la fodera del suo divano. Giovanardi felice: «I due grandi
partiti si sono messi d’accordo…». Ma anche il Cavaliere ora ha paura.
Incassa un Pd in disfacimento, ma l’accordo stipulato ieri pomeriggio
con Bersani non c’è più e il voto di questa mattina, probabilmente,
stabilirà che in questo Parlamento lo spazio per le larghe intese è
strettissimo, sono piccole, piccolissime intese.
L’altro vincitore della serata si chiama Beppe Grillo. Il Pd voleva
spaccare 5 Stelle, ma è finita esattamente in modo opposto: è stato lui,
entrando finalmente in partita con il nome di Stefano Rodotà, a
distruggere il Pd e il centrosinistra. Vendola voterà per il giurista
più amato a sinistra, addio alleanza dell’Italia bene comune. Nel Pd,
alla fine, il voto palese stabilisce 222 sì per Marini e novanta no, il
rifiuto di decidere a voto segreto accende ancora di più gli animi.
Fuori una piccola folla – ci sono anche i professionisti della piazza
come Mascia – insulta i parlamentari del Pd. «Traditori!». E perfino:
«Democristiani!». Sbagliato, perché a chiudere l’accordo con il Giaguaro
ieri è stato il post-comunista Bersani. Ma è la fotografia di un
partito che non si tiene più insieme. Con un pezzo pronto a votare
Rodotà con la sinistra. E un altro che ormai punta alle elezioni e a un
leader chiamato Matteo. Che follia, tenerlo fuori Renzi, ieri sera. Ma
per far scoppiare il Pd non ci voleva il Rottamatore, bastava un
fiammifero spento. E questa mattina vedremo se ci sarà la deflagrazione
del Pd in aula.
da L’Espresso blog

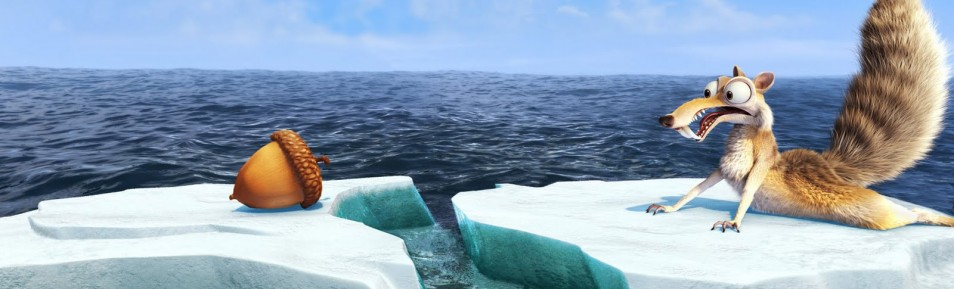
Nessun commento:
Posta un commento