 La
produttività del lavoro dipende dalle innovazioni tecnologiche,
dall’organizzazione della produzione, dalla dimensione e dai settori in
cui le imprese operano; il livello dei salari, normalmente oscillante
attorno alla sussistenza, dipende dalla forza contrattuale dei
lavoratori. Gli stessi dati contenuti nel testo presentato
dal presidente della BCE all’ultimo vertice europeo di Bruxelles, se
inquadrati in una prospettiva logica e temporale differente, confermano
che per circa tre decenni i salari reali in Europa e in tutti i paesi
industrializzati sono cresciuti meno della produttività. Se si considera
la dimensione relativa del salario, le evidenze empiriche disponibili
illustrano una riduzione costante e generalizzata della quota del
reddito nazionale spettante ai lavoratori.
La
produttività del lavoro dipende dalle innovazioni tecnologiche,
dall’organizzazione della produzione, dalla dimensione e dai settori in
cui le imprese operano; il livello dei salari, normalmente oscillante
attorno alla sussistenza, dipende dalla forza contrattuale dei
lavoratori. Gli stessi dati contenuti nel testo presentato
dal presidente della BCE all’ultimo vertice europeo di Bruxelles, se
inquadrati in una prospettiva logica e temporale differente, confermano
che per circa tre decenni i salari reali in Europa e in tutti i paesi
industrializzati sono cresciuti meno della produttività. Se si considera
la dimensione relativa del salario, le evidenze empiriche disponibili
illustrano una riduzione costante e generalizzata della quota del
reddito nazionale spettante ai lavoratori.
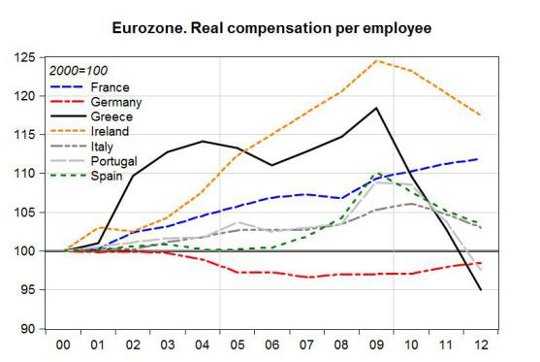
La questione del rapporto tra produttività, salari e distribuzione del reddito è una delle più controverse sia dal punto di vista teorico che della conseguente efficacia delle politiche economiche. La drastica diminuzione del salario registrata negli ultimi 30 anni in tutti i principali paesi industrializzati con la conseguente modifica della sua quota relativamente ai profitti viene spiegata dalla teoria “ortodossa”[1] in questo modo: la dinamica dei salari dipende da quella della produttività del lavoro; se si vogliono aumentare i salari bisogna che cresca la produttività.
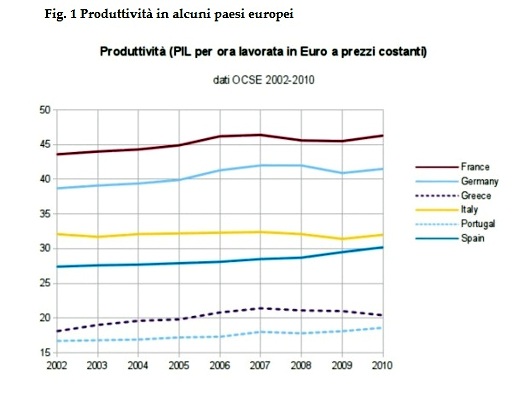
Se
volessimo limitare l’analisi agli ultimi dieci anni dovremmo
registrare che per tutti i paesi europei, tranne – ma in misura
praticamente insignificante – l’Italia, la produttività misurata alla
fine del periodo è più alta di quella di dieci anni prima. Le normali
differenze tra paesi che si registravano nei primi anni del secolo
persistono, con le economie più forti che possono giovarsi di modelli
tecnologici e organizzativi più avanzati di quelli a disposizione degli
altri.
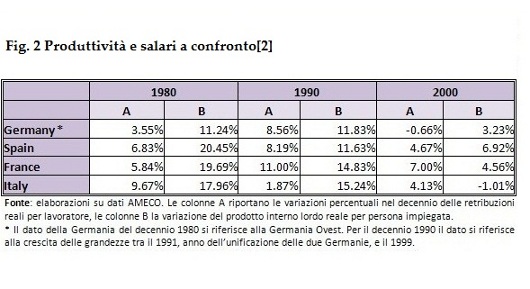
Se
però allarghiamo lo sguardo a un trentennio e mettiamo a confronto i
tassi di crescita della produttività con quelli delle retribuzioni, il
quadro cambia nettamente. In tutti i decenni e in tutti i paesi, tranne
due casi isolati, le retribuzioni reali crescono meno della
produttività. Si può dunque ritenere che i due fenomeni non siano
collegati – o almeno non nella causalità che si intende - e se le
retribuzioni dei lavoratori di alcuni paesi crescono più di quelle di
altri può significare che i livelli di partenza sono più bassi, che le
organizzazioni sindacali sono più combattive, che il tasso di
disoccupazione o di precarietà del lavoro sia diverso, o che sono o non
sono all’opera dispositivi di concertazione, di mediazione, o modelli
di relazione industriale di stampo neocorporativo.
Che non si tratti di un caso limitato all’Europa è confermato dall’ultimo rapporto dell’ILO[3] secondo
il quale solo in un numero ristretto di paesi (Danimarca, Francia,
Finlandia, Regno Unito, Romania e repubblica Ceca) l’aumento della
produttività del lavoro si è riflesso in un aumento dei salari reali;
nelle tre economie più importanti del pianeta: Stati Uniti d’America,
Giappone e Germania, tra il 1999 e il 2007 la produttività del lavoro è
cresciuta, ma i salari reali sono diminuiti, mentre per il resto dei
paesi capitalisticamente sviluppati la correlazione non esiste o è molto
debole.
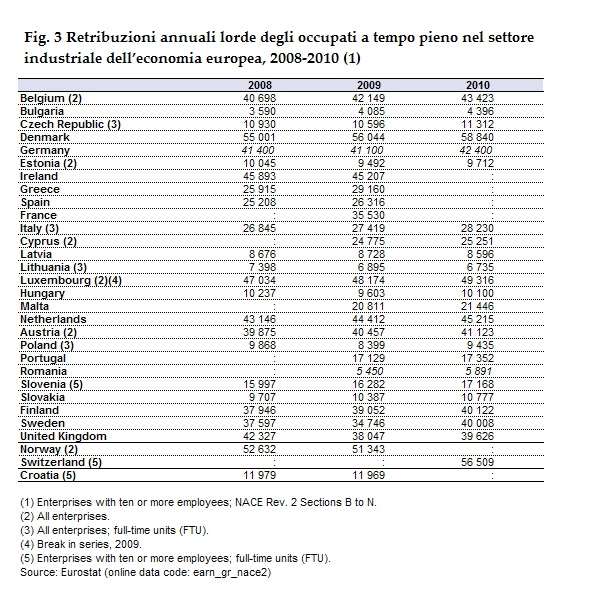
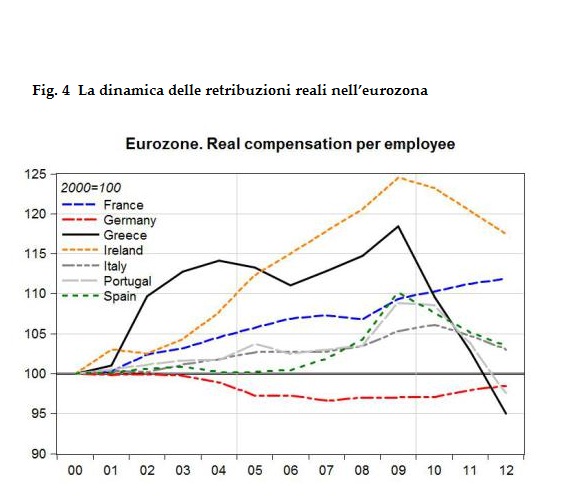
Le
retribuzioni reali dei lavoratori, particolarmente dopo
l’intensificarsi della crisi, sono diminuite drasticamente in tutta
Europa, anche se non nella stessa intensità: il salario di chi lavora in
Grecia[4] è diminuito in tre anni di più del 20%, in
Spagna di quasi il 10%, in Portogallo più del 10%. Tuttavia anche
questi dati vanno considerati assieme a quelli relativi ai livelli
assoluti, in modo da osservare che dopo tre anni di crescita salariale
nel 2008 le retribuzioni medie in Grecia raggiungevano la cifra di
26.000 euro l’anno (al lordo di tasse e contributi) mentre in Germania
il livello era pari a 41.400 euro. Nel 2009, l’anno di picco della
crescita salariale del Portogallo, il salario medio dei lavoratori
arrivava a 17.000 euro. Salari bassi, al livello di sussistenza.
Il costo del lavoro e la sua variabilità
Una
interpretazione solo parzialmente diversa da quella discussa prima è
quella di chi imputa i bassi salari a un costo del lavoro troppo alto
pagato dalle imprese che operano in Italia rispetto al valore aggiunto
prodotto. Anche in questo caso si tratta di una affermazione
discutibile, dal momento che - come è stato osservato su questa rivista[5] -
anche a voler prescindere dai problemi di misurazione il costo del
lavoro medio per occupato resta in Italia basso rispetto ai paesi
concorrenti, solo poco più alto della media dell’Unione Europea (27
paesi) e decisamente più basso che in Gran Bretagna, Francia, Germania e
Svezia.
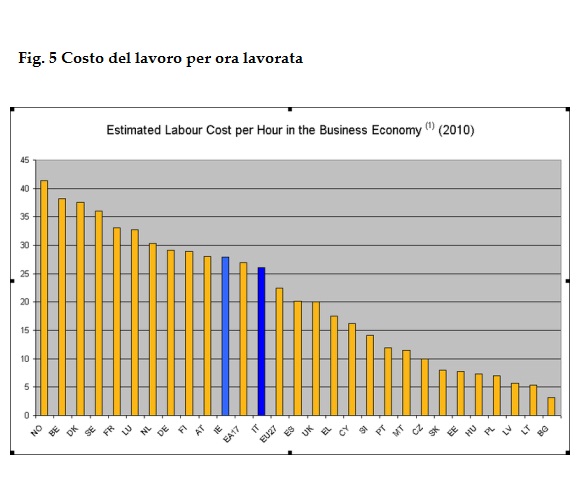
E’ utile ricordare che dentro questo costo sono compresi quegli oneri fiscali e previdenziali che costituiscono il cuneo molto
spesso indicato come causa dei bassi salari. In realtà, se si
considera il salario come l’equivalente del valore della riproduzione
della forza-lavoro, bisogna includere nei costi di riproduzione anche
le tariffe, le imposte e le tasse pagate dai lavoratori per acquistare
quei beni e servizi necessari a garantirsi la sussistenza. In questo
senso, insistere sul problema di un costo del lavoro eccessivo a causa
di un cuneo previdenziale e fiscale troppo alto è una ulteriore
conferma della evidenza che i salari percepiti dai lavoratori sono
bassi oscillando attorno al livello di sopravvivenza.
Euro e deflazione salariale
Se
poi si considera la divergenza intra-europea tra costi del lavoro
prendendo in esame l’intero quarantennio che va dal 1970 al 2010, balza
immediatamente agli occhi come la tendenza alla convergenza, evidente
per un lungo periodo, sia stata bruscamente interrotta dall’introduzione
dell’euro, avvenuta alla fine degli anni ’90.
A partire da quel periodo, mentre per i paesi “core”
il trend del costo del lavoro si è invertito, passando dall’aumento
alla diminuzione, questo non è successo per il gruppo dei GIPS (Grecia,
Italia, Portogallo, Spagna). Questo aspetto merita di essere
sottolineato: nonostante dal punto di vista statistico sia evidentemente
la stessa cosa, non è successo che, a causa dell’euro, i paesi GIPS
abbiano visto modificarsi il proprio trend di “naturale” crescita del
costo del lavoro: la curva mantiene praticamente la stessa pendenza
prima e dopo l’euro; è successo invece per pochissimi paesi forti
(sostanzialmente la Germania e i paesi nordeuropei) che l’introduzione
di una valuta più debole di quella che avevano precedentemente abbia
coinciso con una riduzione del costo del lavoro.
Non c’è dubbio che le aree valutarie
siano uno strumento ottimale per scaricare la crisi sul salario. In un
sistema di cambi flessibili, se le imprese localizzate in un
determinato paese sperimentano un deficit di competitività, possono
tentare di riguadagnare quote di mercato (ovviamente a spese di imprese
localizzate in un paese diverso, è da non dimenticare che si tratta in
questo caso di un tipico gioco a somma zero) utilizzando la leva del
cambio. Come è noto, una riduzione del valore della valuta nazionale –
coeteris paribus – può aiutare le imprese esportatrici a vendere di più
all’estero; si tratta di manovre che storicamente le autorità
monetarie e i governi hanno attuato e che anche oggi rappresentano
un’arma importante nella competizione tra aree valutarie transnazionali.
Con una sola valuta continentale che sostituisce quelle nazionali, la
manovra non è evidentemente utilizzabile per riaggiustare differenziali
di competitività interni all’area stessa, obiettivo che in questo caso
si può realizzare solo attraverso manovre di “deflazione interna”,
ossia scaricando il costo della crisi su chi lavora nei paesi che
stanno perdendo competitività.
Che questo non sia una mera conseguenza casuale del funzionamento delle aree valutarie
ma un obiettivo coscientemente perseguito dai policy-makers non è una
illazione, dal momento che a confermarlo ci ha pensato lo stesso
massimo teorico delle aree valutarie Robert Mundell[6] ma,
se si pensa che il giudizio dipenda dalla prospettiva teorica di
Mundell (un liberale che si colloca su posizioni definibili di destra
sul piano politico generale, vicino al partito repubblicano), è il caso
di ricordare come il suo collega premio Nobel Paul Krugman, che viene
generalmente accreditato di posizioni politiche progressiste, ha
dichiarato candidamente a Le Monde che, “Pour
restaurer la compétitivité en Europe, il faudrait que, disons d’ici
les cinq prochaines années, les salaires baissent, dans les pays
européens[7]“.
Salari
ancora più bassi non ci sembrano una prospettiva particolarmente
allettante. In generale e soprattutto se si considera la dinamica
salariale nella dimensione più rilevante in cui deve essere analizzata, e
cioè in termini relativi, ossia in relazione all’intero reddito
nazionale prodotto e distribuito. I dati inseriti in un recente
contributo di Antonella Stirati[8] non sembra abbiano bisogno di ulteriori commenti.
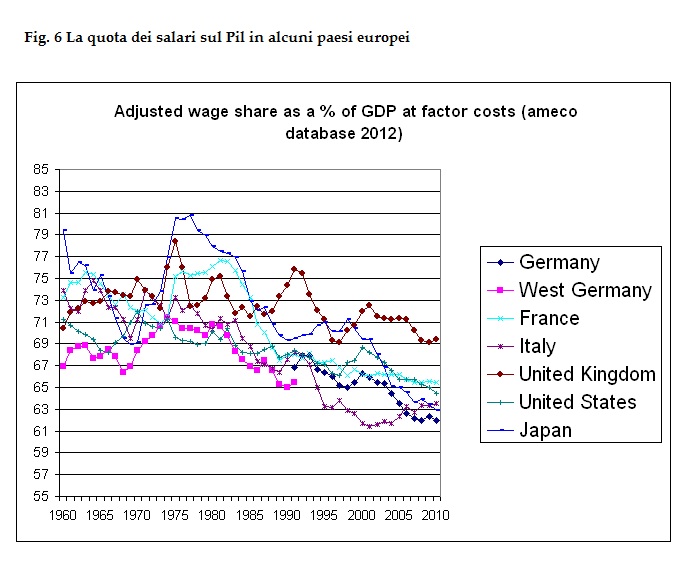
In
conclusione, prescindendo da un giudizio sulla possibilità e sulla
desiderabilità di un ulteriore aumento della produttività, è possibile
sostenere che:
1. La
produttività del lavoro, e dunque il livello di sviluppo raggiunto
dalle forze produttive, è storicamente alta, anzi altissima, in
occidente e dunque nei paesi europei capitalisticamente sviluppati;
2..
La circostanza per cui in un determinato periodo la produttività sia
cresciuta in un gruppo di paesi più che in un altro può dipendere dagli
investimenti in innovazioni tecnologiche, da scelte (o non scelte)
politiche e strategiche, dalla dimensione media o dalla specializzazione
settoriale delle imprese che operano in un determinato paese;
3.
Che una maggiore produttività si traduca in più alti salari è una
evidenza che non esiste a livello empirico, mentre tipicamente accade il
contrario: un maggiore valore aggiunto prodotto per lavoratore
occupato, anche a voler prescindere dei suoi “sbocchi”, in particolare
nelle fasi in cui la domanda internazionale è debole, corrisponde da
molti anni a questa parte a una minore e più precaria occupazione che a
sua volta si traduce in una maggiore competizione sul mercato del
lavoro che indebolisce la lotta per aumenti salariali.
4.
La crisi non colpisce tutte le classi sociali allo stesso modo: la
quota di salari diminuisce e quella destinata ai profitti cresce.

Nessun commento:
Posta un commento