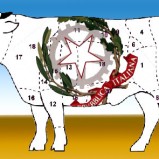
Intervenendo al recente G20 di Mosca, il ministro Saccomanni ha
ventilato l’ipotesi della vendita di quote dei gioielli industriali
pubblici per fare cassa, cui è seguita la smentita di prammatica. Dunque
la conferma di quanto scrivevamo su queste pagine riguardo a
Finmeccanica. Da più parti è stata avanzata l’opportunità di preservare
il controllo nazionale su aziende strategiche, scatenando la reazione
contraria dei liberisti mimetizzati tra le pagine dei principali
quotidiani nazionali: italianità? Roba da gente che non comprende il
(sacro) funzionamento dei mercati finanziari.
Al massimo si può discutere l’obiezione già avanzata da Mario Monti, quando ancora era Supermario, sul momento poco favorevole per messe all’incanto. Insomma, questi grandi mercatisti non oltrepassano l’orizzonte più ristretto di un bottegaio. Difatti la riflessione sulla strategicità consente di porre la questione sotto ben altra prospettiva; quella del soggetto abscondito negli ultimi decenni del dibattito pubblico nazionale: la politica industriale. Questione diventata drammatica dal momento in cui la scomparsa della Grande Fabbrica e l’esaurirsi dell’epopea distrettuale lasciano sul campo un sistema produttivo affetto da nanismo, capace di perdere fette del mercato mondiale per cronica incapacità di innovare. Il governo Letta dichiara di iscrivere a priorità la lotta alla disoccupazione giovanile: far ripartire l’economia al fine di creare nuovi posti di lavoro. Obiettivo lodevole, quanto destinato a fallire per la percezione della realtà che sottende: un contesto produttivo in vincoli per i costi dei fattori e per eccesso di regolazione. Le nostre imprese sarebbero una sorta di Gulliver, pronto a spiccare il salto se non fosse impacciato dai mille lacci e laccioli di ipotetici lilipuzziani. Ma è questa la realtà? In effetti il nostro sistema d’impresa è andato in crisi negli anni ’70 ritirandosi dai settori tecnologicamente avanzati e ad alto capitale, in quanto incapace di adattarsi al nuovo contesto competitivo. Sicché dal fatidico 1980 rimane al di sotto degli andamenti dei paesi concorrenti. Difatti produciamo beni sempre meno appetibili. Pensare di risolvere la questione occupazionale dando sempre maggiore mano libera a questo sistema d’impresa è pura illusione. La domanda da porsi è se la nostra struttura industriale attuale e le sue specializzazioni sono adeguate a rilanciare la crescita. Le 5mila imprese medie (pari al 7,7% dell’intero universo nazionale con 1 milione di occupati), che le indagini di Bankitalia ci assicurano tecnologicamente strutturate, non sembrano in grado di trainare salti di qualità. Anche per i settori in cui ci siamo parcheggiati, poveri di tecnologia e facilmente imitabili: arredamento, abbigliamento, alimentare e automazione. Negli anni ’90 una delle principali voci dell’export verso i mercati americani era il grés da Sassuolo. Oggi, dopo aver esportato macchinari per la fabbricazione di laterizi in Cina, aver inviato tecnici per avviarne le produzioni, il grés in Usa è cinese. Solo un esempio dei danni della riproducibilità. Appurata la totale assenza di una strategia nazionale per uscire dall’ impasse , sarebbe importante favorire l’affermazione di nuovi campioni nazionali posizionati in ambiti più trainanti di quelli attualmente in campo, dall’occhialeria di Luxottica alla calzatura. Ma anche indurre riposizionamenti di gamma dei nostri prodotti; vedi le costruzioni navali di Fincantieri, impossibilitata a competere sul solo prezzo con la concorrenza coreana. Lo stesso problema dell’industria automobilistica tedesca, superato qualificando la propria merceologia in fascia alta. In altre parole il rilancio dello sviluppo e la creazione di nuovo lavoro richiede approcci volontaristici agli antipodi del laissez faire liberista; la cui stagione tramonta nel mondo ma che sussiste nelle enclaves attardate, quale il Bel Paese in pieno declino industriale.
Al massimo si può discutere l’obiezione già avanzata da Mario Monti, quando ancora era Supermario, sul momento poco favorevole per messe all’incanto. Insomma, questi grandi mercatisti non oltrepassano l’orizzonte più ristretto di un bottegaio. Difatti la riflessione sulla strategicità consente di porre la questione sotto ben altra prospettiva; quella del soggetto abscondito negli ultimi decenni del dibattito pubblico nazionale: la politica industriale. Questione diventata drammatica dal momento in cui la scomparsa della Grande Fabbrica e l’esaurirsi dell’epopea distrettuale lasciano sul campo un sistema produttivo affetto da nanismo, capace di perdere fette del mercato mondiale per cronica incapacità di innovare. Il governo Letta dichiara di iscrivere a priorità la lotta alla disoccupazione giovanile: far ripartire l’economia al fine di creare nuovi posti di lavoro. Obiettivo lodevole, quanto destinato a fallire per la percezione della realtà che sottende: un contesto produttivo in vincoli per i costi dei fattori e per eccesso di regolazione. Le nostre imprese sarebbero una sorta di Gulliver, pronto a spiccare il salto se non fosse impacciato dai mille lacci e laccioli di ipotetici lilipuzziani. Ma è questa la realtà? In effetti il nostro sistema d’impresa è andato in crisi negli anni ’70 ritirandosi dai settori tecnologicamente avanzati e ad alto capitale, in quanto incapace di adattarsi al nuovo contesto competitivo. Sicché dal fatidico 1980 rimane al di sotto degli andamenti dei paesi concorrenti. Difatti produciamo beni sempre meno appetibili. Pensare di risolvere la questione occupazionale dando sempre maggiore mano libera a questo sistema d’impresa è pura illusione. La domanda da porsi è se la nostra struttura industriale attuale e le sue specializzazioni sono adeguate a rilanciare la crescita. Le 5mila imprese medie (pari al 7,7% dell’intero universo nazionale con 1 milione di occupati), che le indagini di Bankitalia ci assicurano tecnologicamente strutturate, non sembrano in grado di trainare salti di qualità. Anche per i settori in cui ci siamo parcheggiati, poveri di tecnologia e facilmente imitabili: arredamento, abbigliamento, alimentare e automazione. Negli anni ’90 una delle principali voci dell’export verso i mercati americani era il grés da Sassuolo. Oggi, dopo aver esportato macchinari per la fabbricazione di laterizi in Cina, aver inviato tecnici per avviarne le produzioni, il grés in Usa è cinese. Solo un esempio dei danni della riproducibilità. Appurata la totale assenza di una strategia nazionale per uscire dall’ impasse , sarebbe importante favorire l’affermazione di nuovi campioni nazionali posizionati in ambiti più trainanti di quelli attualmente in campo, dall’occhialeria di Luxottica alla calzatura. Ma anche indurre riposizionamenti di gamma dei nostri prodotti; vedi le costruzioni navali di Fincantieri, impossibilitata a competere sul solo prezzo con la concorrenza coreana. Lo stesso problema dell’industria automobilistica tedesca, superato qualificando la propria merceologia in fascia alta. In altre parole il rilancio dello sviluppo e la creazione di nuovo lavoro richiede approcci volontaristici agli antipodi del laissez faire liberista; la cui stagione tramonta nel mondo ma che sussiste nelle enclaves attardate, quale il Bel Paese in pieno declino industriale.

Nessun commento:
Posta un commento