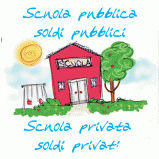Le parole per dirlo
È da tempo che il linguaggio della
“politica” ha assunto – pagando i “creativi” per riuscirci – i toni e le
forme della pubblicità. Non più discorsi, ma frasi; non più slogan, ma
singole parole; non più leader che sappiano suscitare reazioni
collettive, ma personaggiuzzi capaci di recitare con i tempi e le
faccette giuste, per catalizzare su di sé la delega ed evitare reazioni collettive.
Esperimenti in corpore vili di
spossessamento perenne della “volontà popolare”, tipici di un paese che
spesso è stato il “laboratorio degli orrori”, l'elaboratore di un format
reazionario che poi altri hanno adottato con successo. Il fascismo, per
esempio.
Coerentemente con i tempi, dunque, ci sono due parole che dominano la retorica del potere: stabilità e flessibilità.
Entrambe declinate in funzione dell'obiettivo supremo di questa fase di
crisi, ovvero un'altra parola dal suono vagamente minaccioso: competitività.
Una trinità ben poco virtuosa, anche se tutti i media center sono
stati attivati per cantarne le lodi. Non si può essere competivi se non
c'è stabilità politica, ovvero annullamento della dialettica politica e
parlamentare, altrimenti i mercati possono cogliere questo elemento di
debolezza per alzare la pressione speculativa sulla nostra economia o i
titoli di stato. Non si può diventare più competitivi se il lavoro non
diventa ancora più flessibile, plasmabile a piacere, liquido,
evanescente, poco costoso, possibilmente gratuito.
Sulla competitività non c'è e non ci può
essere discussione pubblica. Persino i tardo-keynesiani che si affannano
ad avanzare robuste critiche alle politiche di austerity sono costretti
a presentare le proprie ricette come più efficaci ai fini della
competitività. È un articolo di fede, non un tema di dibattito. Non si
deve più convincere nessuno, è così.
La stabilità invece inquieta i residui spiriti democratici. Barbara Spinelli, addirittura sull'house organ del Quirinale (Repubblica), ha lanciato il suo lucido e storiograficamente colto j'accuse:
“Stabilità: così spesso viene invocata e
così febbrilmente, in Italia, che quasi non ci accorgiamo che è divenuta
virtù teologale che assorbe ogni altra virtù: non mezzo, ma finalità
ultima dell'agire politico. Non siamo i soli a subirne i ricatti: in
tutta Europa, le ricette anticrisi l'assolutizzano. [...]
Quotidianamente vengono additati i nemici della stabilità politica, e
piano piano ogni inquietudine, ogni opposizione, ogni giornale che
amplifichi notizie poco gradite al comando son guardati con diffidenza.
[…] La stabilità assurge a valore supremo, non negoziabile, e se
vogliamo custodirla dobbiamo disgiungerla da princìpi democratici
essenziali come l'imperio della legge, la responsabilità del governante,
la sua imputabilità: tutte cose che turbano. Viviamo nel regno della
necessità e del sonno, non della libertà e del divenire. Non c'è
alternativa alle larghe intese, da cui ci si attende nientemeno che la
pace, o meglio la pacificazione. […] Ci sono momenti in cui si ha
l'impressione che l'Italia abbia vissuto nel Regno della Necessità quasi
sempre, tranne nel momento magico del Comitato di liberazione
nazionale, della Costituzione repubblicana. I governanti che sono venuti
dopo sono stati potenti stabilizzatori, più che responsabili. Quando
parla al popolo, lo stabilizzatore gli dà poco rispettosamente del tu e
d'istinto cade nel frasario del gangster: "Ti faccio un'offerta che non
potrai rifiutare".
Difficile non essere d'accordo, anche se
da una diversa prospettiva. Difficile non cogliere la disperata denuncia
e il paragone – davvero hard, tanto che nessuno l'ha ripreso –
tra Napolitano e Hindemburg, il presidente della repubblica di Weimar
che aprì consapevolmente le porte al nazismo.
La stabilità è il bisogno del potere, la sicurezza di non trovare inciampi, fossero anche 24 ore di ostruzionismo parlamentare.
La flessibilità è un comandamento sulla popolazione in
età da lavoro. Il “modello Expo” che Letta il Giovane vorrebbe
estendere a tutta Italia, in nome della competitività e dell'aumento
dell'occupazione, produrrà la bellezza di 800 posti a tempo determinato e
1800 “volontari”, ovvero lavoratori non retribuiti. Difficile far
meglio, senza arrivare all'asino del contadino avaro.
Il punto terminale di questo lento
logorìo della vita politica, in piena crisi sociale, è quindi facile da
identificare. È un obiettivo perseguito con determinazione al livello
dei Napolitano, Draghi, Marchionne, Letta; con sguaiatezza e secondari
obiettivi personali o di clientela da parte dei berlusconidi.
L'”instabilità” di cui si lamentano i palazzi deriva da questa
disomogeneità, propria di un personale politico raffazzonato, spurio, di
bassa lega. Non è un problema irrisolvibile e forse l'estromissione del
Cavaliere dalla scena politica potrebbe persino aiutare... Forse no, se
prevarrà in quella fetta di blocco sociale pre-capitalistico la
tentazione di giocare populisticamente contro l'evidente “governo
sovranazionale”, magari ridotto alla sola Germania merkeliana.
Ma l'obiettivo è identico: stabilità per chi governa il paese o le imprese, autoritarismo senza mezzi termini, riduzione a niente dell'opposizione politica e sociale; flessibilità – ovvero subordinazione assoluta, senza alcuna resistenza – per tutti gli altri.
È la partita che si gioca in autunno. La quarta parola che infatti fa capolino nel discorso pubblico è rivolta.
È fisicamente impossibile che la compressione violenta delle condizioni
di vita e di libertà non produca prima o poi una qualche forma di
esplosione di “rabbia”. Lo sa bene persino Letta il Razionale, più che
Casaleggio il Visionario. La rivolta è attesa, temuta, esorcizzata. E si
preparano a combatterla. Lo schema di ingaggio appare già in queste
settimane, l'hanno provato in Val Susa esattamente come fecero a Napoli,
due mesi prima di Genova 2001. La “lettere minatorie” fanno parte
integrante dello stesso schema, oggi come allora. Magari con gli
Esposito al posto dei Gasparri...
La ratio di una repressione
sproporzionata rispetto alle prime manifestazioni di protesta è vecchia
quanto l'esercizio del potere: spaventare subito, restringere il cerchio
della simpatia, bloccare il contagio. Qualche volta ottiene l'effetto
(dopo Genova 2001, in effetti, “il movimento” s'è arrestato); quancke
volta no, anzi peggiora la situazione.
Dobbiamo saperlo anche tutti noi. Evitare
di offrire il collo al boia, far avanzare il movimento “tra la gente”;
praticare il conflitto sapendo che si tratterà di un lungo periodo, non
dell'urlo di un giorno.
Ci vogliono flessibili, saremo stabili. Ma in movimento.