 Un tratto comune delle rivolte contro i sistemi in questi ultimi anni
sembra essere l’occupazione di spazi pubblici simbolici. Occupy Wall
Street, Occupy LSX. Puerta del Sol, Piazza Taksim, Piazza Tahrir, Piazza
Syntagma e altre meno conosciute topografie della protesta sono
rimbalzate sulle pagine dei giornali, nei siti web, nei telegiornali.
Un tratto comune delle rivolte contro i sistemi in questi ultimi anni
sembra essere l’occupazione di spazi pubblici simbolici. Occupy Wall
Street, Occupy LSX. Puerta del Sol, Piazza Taksim, Piazza Tahrir, Piazza
Syntagma e altre meno conosciute topografie della protesta sono
rimbalzate sulle pagine dei giornali, nei siti web, nei telegiornali.La seconda caratteristica delle “rivolte” è che, nessuno di questi movimenti ha espresso un leader riconoscibile o un programma che andasse al di là del “no” ad un situazione. I movimenti si sono sciolti, raramente hanno colto l’obiettivo che si proponevano e, anche quando l’hanno ottenuto, non hanno prodotto un cambiamento che hanno poi, in qualche modo, governato in prima persona.
Nei rari casi nei quali il cambiamento è avvenuto (penso all’Egitto dove ancora tutto è magmatico) il movimento non ha recitato un ruolo di guida. Nei molti casi nei quali il cambiamento non è avvenuto il movimento si è liquefatto ed è tornato ad essere marginale ed irrilevante. In Italia nessun luogo simbolico è stato occupato, la gente non è scesa in una piazza, non c’è stato nulla di analogo. Alcuni hanno detto (Wu Ming) che il mancato verificarsi di questo tipo di proteste nel nostro Paese, sia la conseguenza della crescita del Movimento Cinque Stelle che avrebbe assorbito la pulsione alla protesta. Il che spiega però le cose in modo parziale.
Il primo problema è – secondo me – che i movimenti che sono sorti sino ad oggi e che si sono espressi con queste modalità hanno espresso un malessere indefinito che non è riuscito a definirsi in termini concreti. Soltanto i manifestanti turchi ed egiziani avevano una chiara idea dei loro obiettivi. Si trattava, in questi casi, di rovesciare un regime con la pressione popolare. Ma anche qui non è mai emerso un disegno di società che andasse al di là di affermazioni generiche (“più laicismo”, “più democrazia”). Il secondo problema è che la maggior parte di questi movimenti vuole essere onnicomprensivo. “Noi siamo il 99%” è lo slogan che, con maggiore forza, esprime questo desiderio. Onnicomprensività che è figlia di un altro slogan “né di Destra, né di Sinistra”. L’illusione è che intorno a temi generici si possano coagulare storie differenti. L’idea è che un movimento politico possa dichiararsi – di fatto – apolitico, ossia fuori dagli schemi tradizionali. Un movimento cui si aderisce nel nome di un obiettivo così largo che si identifica in un disagio diffuso. Aderire ad un movimento contro l’austerity è facile: basta essere colpiti dalla austerity. Più difficile è aderire ad un movimento che, oltre ad essere “contro” elabori un progetto di società alternativa. Ecco perché, molto spesso, i movimenti si definiscono “non-movimenti”, ossia grandi aggregazioni con una idea precisa su ciò che non si vuole e una idea evanescente di quello che si vorrebbe creare.
Un movimento che scelga di essere onnicomprensivo non può però disegnare un futuro. Perché su quella idea di futuro esploderebbe il “99%”. Possiamo marciare tutti uniti solo a patto di avere come collante unitario il disagio verso qualcosa. Questo è il limite di ogni movimento che si è espresso sino a questo momento.
In Italia alcuni temi hanno favorito il mito del “99%” e quello che ha
avuto maggiore successo è quello della “kasta”. La “kasta” è di per sé
un denominazione che si applica ad un numero ristretto di soggetti che
possono ricadere bene nell’1%. Se poi la “kasta” viene identificata
nella classe politica dirigente diventa ancora più facile. Poco importa
che, all’interno del 99%, ci siano altre “kaste” meno visibili: renderle
visibili manderebbe in pezzi la coesione. Coesione che si traduce nel
generico “tutti ladri”. Il “tutti ladri” non ha solo la funzione di
arruolare nel 99% provenienze ideali che farebbero a pugni tra loro, ha
anche una funzione catartica, di assoluzione totale. Nasce così un altro
mito: quello del “popolo buono e vittima”. Questo mito autoassolve il
99% da qualsiasi pregressa responsabilità politica degli ultimi venti o
trent’anni. Un gregge di pecore buone ingannato dalla “kasta”, mai
complice con essa, mai contiguo che, finalmente, trova il coraggio di
reagire. Insomma una riedizione in salsa moderna delle parole di
Goffredo Mameli: “che se il popolo si desta, Dio combatte alla sua
testa. La sua folgore gli dà”.
Dunque, per la nascita di un movimento in questi tempi, sembra necessaria la presenza di tre elementi: un disagio collettivo unificante, una “kasta” da condannare la cui presenza ci assolve tutti e ci trasforma nei “buoni”, un rigoroso silenzio sul futuro che potrebbe essere non condiviso da tutti.
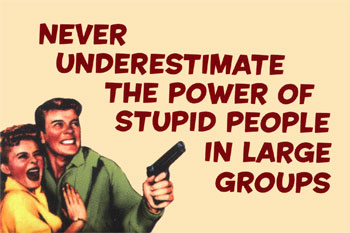 Il movimento che si crea con queste tre premesse può essere tutto ma,
sicuramente, non ha alcuna caratteristica rivoluzionaria. Al contrario è
un movimento che cerca di “riparare” la realtà e che neppure si sogna
di contestarla alle radici. Per capire questa pulsione a “riparare”
piuttosto che a “superare”, il tema dell’uscita dall’Euro è
particolarmente adatto.
Il movimento che si crea con queste tre premesse può essere tutto ma,
sicuramente, non ha alcuna caratteristica rivoluzionaria. Al contrario è
un movimento che cerca di “riparare” la realtà e che neppure si sogna
di contestarla alle radici. Per capire questa pulsione a “riparare”
piuttosto che a “superare”, il tema dell’uscita dall’Euro è
particolarmente adatto.
Qui non si vuole sostenere che si dovrebbe restare nell’Euro, né si vuole sostenere che bisognerebbe uscirne. Le ragioni di una parte piuttosto che dell’altra non ci interessano. Ci interessa vedere come funziona il meccanismo che aggrega intorno al tema della uscita dell’Euro un numero crescente di soggetti diversissimi per cultura politica e segmentazione sociale.
In primo luogo c’è un disagio oggettivo e diffuso: la crisi economica. Vivere la crisi affratella e crea il mito del “99%”. Così l’operaio e il suo padrone possono ritrovarsi in un disagio comune che li rende alleati. Il ricco come il povero – sotto i colpi della crisi – sono diventati rispettivamente meno ricchi e più poveri. Ogni classe sociale (che poi è diventata solo classe di reddito) sente di aver perduto qualcosa e questo senso di perdita fa superare le diversità che dividono. In secondo luogo c’è una “kasta” che rappresenta l’1%: i politici che hanno tradito il popolo e un nemico storico che si è arricchito mentre noi ci impoverivamo: i tedeschi. E ancora si sente rieccheggiare Goffredo Mameli: “All’incirca son trent’anni che scendevano su Genova, l’armi in spalla gli Alemanni”. In terzo luogo non c’è un futuro da costruire ma un passato da fa rivivere: la moneta nazionale.
Leggere tutti i libri che sono stati scritti contro l’Euro è istruttivo. Pur con sfumature diverse, tutti gli autori pervengono alla conclusione che la soluzione al disagio sia tornare indietro, ad una soluzione precedente.
Ma questo ritorno indietro esprime la volontà di un movimento di cambiare radicalmente e realmente la società? No. Il ritornare indietro è un miltoniano ritorno al paradiso perduto. Alla possibilità di stampare moneta, di svalutare per favorire la competitività.
Ed ecco la parola magica: “competitività”. Recuperare la “competitività” significa lavorare per riacquistare il benessere perduto, per riavere la capacità di comprare di nuovo, per essere nuovamente “performanti” dentro al grande circo del capitalismo. Perché nessuno di quelli che contestano l’euro contesta con pari forza il sistema che ha creato l’euro: il capitalismo globale. Contestarlo significherebbe buttare tra le gambe del 99% un tema che dividerebbe, una visione del futuro che farebbe perdere coesione. Sarebbe far inciampare il movimento su qualcosa che non prevede: immaginare un futuro. Così il movimento contro l’euro diventa un movimento dedito alla riparazione del sistema che ha provocato la crisi. Non è in contestazione il capitalismo in sé, che è (evidentemente) buono sino a quando garantisce una soddisfacente fetta di torta a ciascuno. Una fetta piccolina per i subalterni, una fetta un po’ più grossa per la classe media, una fetta generosa per le classi dirigenti. Quello che è oggetto di contestazione è il capitalismo finanziario malato. Malato perché sta distribuendo fette di torta troppo piccole alla maggioranza e fette di torta troppo generose ad una minoranza. In questo senso il movimento anti-euro non mette in discussione un sistema economico: più semplicemente reclama che funzioni “bene”, ossia che ridistribuisca in modo accettabile e più equo le risorse. Concetti come “crescita”, “PIL”, “consumo” non vengono contestati o sottoposti ad una critica: sono strumenti per misurare il buono stato di salute di un capitalismo “dal volto umano”. Il movimento anti-euro è restauratore per definizione ed è quanto di più lontano da qualsiasi idea di cambiamento del sistema. Per questo può trovare un consenso sempre più largo. Ci sono due pericoli però. Il primo è che – per uno di quegli scherzi tipici del capitalismo – si affermi una ripresa sostanziale in grado dare un relativo sollievo al disagio. In questo caso il “99%” perderebbe pian piano una percentuale via via crescente: i “salvati” lascerebbero il campo dei “sommersi”. Il secondo è che, completata l’uscita, la corsa a riprendersi la propria fetta di torta (se disponibile) faccia esplodere il movimento.
Concludendo, il movimento anti-euro in Italia è la cosa più simile alle occupazioni delle piazze negli altri Paesi. Ha gli stessi punti di forza e gli stessi punti di debolezza. Ma, come le piazze in giro per il mondo, per mantenere unito un eterogeneo 99% non può permettersi il lusso di disegnare un progetto di futuro. Però se non si può disegnare un futuro non si ha nessun futuro cui tendere. Come in una classica rivolta per il pane, una volta tornata la disponibilità nelle panetterie ad un prezzo equo, la rivolta si placherà. La piazza si svuoterà e tutto ricomincerà come prima. Fino alla prossima crisi.
Dunque, per la nascita di un movimento in questi tempi, sembra necessaria la presenza di tre elementi: un disagio collettivo unificante, una “kasta” da condannare la cui presenza ci assolve tutti e ci trasforma nei “buoni”, un rigoroso silenzio sul futuro che potrebbe essere non condiviso da tutti.
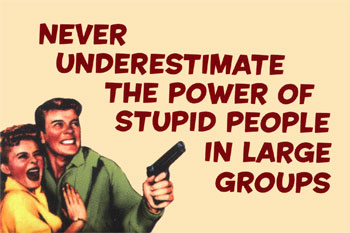 Il movimento che si crea con queste tre premesse può essere tutto ma,
sicuramente, non ha alcuna caratteristica rivoluzionaria. Al contrario è
un movimento che cerca di “riparare” la realtà e che neppure si sogna
di contestarla alle radici. Per capire questa pulsione a “riparare”
piuttosto che a “superare”, il tema dell’uscita dall’Euro è
particolarmente adatto.
Il movimento che si crea con queste tre premesse può essere tutto ma,
sicuramente, non ha alcuna caratteristica rivoluzionaria. Al contrario è
un movimento che cerca di “riparare” la realtà e che neppure si sogna
di contestarla alle radici. Per capire questa pulsione a “riparare”
piuttosto che a “superare”, il tema dell’uscita dall’Euro è
particolarmente adatto.Qui non si vuole sostenere che si dovrebbe restare nell’Euro, né si vuole sostenere che bisognerebbe uscirne. Le ragioni di una parte piuttosto che dell’altra non ci interessano. Ci interessa vedere come funziona il meccanismo che aggrega intorno al tema della uscita dell’Euro un numero crescente di soggetti diversissimi per cultura politica e segmentazione sociale.
In primo luogo c’è un disagio oggettivo e diffuso: la crisi economica. Vivere la crisi affratella e crea il mito del “99%”. Così l’operaio e il suo padrone possono ritrovarsi in un disagio comune che li rende alleati. Il ricco come il povero – sotto i colpi della crisi – sono diventati rispettivamente meno ricchi e più poveri. Ogni classe sociale (che poi è diventata solo classe di reddito) sente di aver perduto qualcosa e questo senso di perdita fa superare le diversità che dividono. In secondo luogo c’è una “kasta” che rappresenta l’1%: i politici che hanno tradito il popolo e un nemico storico che si è arricchito mentre noi ci impoverivamo: i tedeschi. E ancora si sente rieccheggiare Goffredo Mameli: “All’incirca son trent’anni che scendevano su Genova, l’armi in spalla gli Alemanni”. In terzo luogo non c’è un futuro da costruire ma un passato da fa rivivere: la moneta nazionale.
Leggere tutti i libri che sono stati scritti contro l’Euro è istruttivo. Pur con sfumature diverse, tutti gli autori pervengono alla conclusione che la soluzione al disagio sia tornare indietro, ad una soluzione precedente.
Ma questo ritorno indietro esprime la volontà di un movimento di cambiare radicalmente e realmente la società? No. Il ritornare indietro è un miltoniano ritorno al paradiso perduto. Alla possibilità di stampare moneta, di svalutare per favorire la competitività.
Ed ecco la parola magica: “competitività”. Recuperare la “competitività” significa lavorare per riacquistare il benessere perduto, per riavere la capacità di comprare di nuovo, per essere nuovamente “performanti” dentro al grande circo del capitalismo. Perché nessuno di quelli che contestano l’euro contesta con pari forza il sistema che ha creato l’euro: il capitalismo globale. Contestarlo significherebbe buttare tra le gambe del 99% un tema che dividerebbe, una visione del futuro che farebbe perdere coesione. Sarebbe far inciampare il movimento su qualcosa che non prevede: immaginare un futuro. Così il movimento contro l’euro diventa un movimento dedito alla riparazione del sistema che ha provocato la crisi. Non è in contestazione il capitalismo in sé, che è (evidentemente) buono sino a quando garantisce una soddisfacente fetta di torta a ciascuno. Una fetta piccolina per i subalterni, una fetta un po’ più grossa per la classe media, una fetta generosa per le classi dirigenti. Quello che è oggetto di contestazione è il capitalismo finanziario malato. Malato perché sta distribuendo fette di torta troppo piccole alla maggioranza e fette di torta troppo generose ad una minoranza. In questo senso il movimento anti-euro non mette in discussione un sistema economico: più semplicemente reclama che funzioni “bene”, ossia che ridistribuisca in modo accettabile e più equo le risorse. Concetti come “crescita”, “PIL”, “consumo” non vengono contestati o sottoposti ad una critica: sono strumenti per misurare il buono stato di salute di un capitalismo “dal volto umano”. Il movimento anti-euro è restauratore per definizione ed è quanto di più lontano da qualsiasi idea di cambiamento del sistema. Per questo può trovare un consenso sempre più largo. Ci sono due pericoli però. Il primo è che – per uno di quegli scherzi tipici del capitalismo – si affermi una ripresa sostanziale in grado dare un relativo sollievo al disagio. In questo caso il “99%” perderebbe pian piano una percentuale via via crescente: i “salvati” lascerebbero il campo dei “sommersi”. Il secondo è che, completata l’uscita, la corsa a riprendersi la propria fetta di torta (se disponibile) faccia esplodere il movimento.
Concludendo, il movimento anti-euro in Italia è la cosa più simile alle occupazioni delle piazze negli altri Paesi. Ha gli stessi punti di forza e gli stessi punti di debolezza. Ma, come le piazze in giro per il mondo, per mantenere unito un eterogeneo 99% non può permettersi il lusso di disegnare un progetto di futuro. Però se non si può disegnare un futuro non si ha nessun futuro cui tendere. Come in una classica rivolta per il pane, una volta tornata la disponibilità nelle panetterie ad un prezzo equo, la rivolta si placherà. La piazza si svuoterà e tutto ricomincerà come prima. Fino alla prossima crisi.

Nessun commento:
Posta un commento